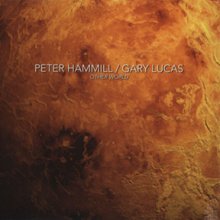di Walter Catalano
9) Sigur Rós. Kveikur, 2013
Restiamo in Islanda. E questa volta andiamo sul classico con i Sigur Rós che ad un anno esatto dall’evanescente e rarefatto “Valtari”, invertono la rotta e – complice probabilmente qualche rimpasto dell’organico: la dipartita dal gruppo dello storico tastierista Kjartan – propongono per questo loro settimo album, un sound decisamente rock e a tratti quasi industrial con abbondanza di chitarre e percussioni, piuttosto inusitato per loro. Più duro ma anche più immediato ed energetico, talvolta quasi pop, il disco ha un impatto e una digeribilità immediata che riportano – pur nella totale differenza – al loro capolavoro “Ágætis byrjun” (1999): una sorta di nuovo inizio su altre basi. Acceso lo “stoppino” (questo il significato del titolo), la bomba deflagra e gli islandesi, ridotti a trio, disertando quasi del tutto l’ambient e il post-rock, si lasciano andare con compiacimento a ritmi molto meno esangui. Numerosi fan e alcuni critici hanno storto il naso per questo nuovo corso e hanno definito il disco “furbetto”, ma a me è piaciuto parecchio lo stesso.
10) St.Vincent, St.Vincent, 2014
A qualcuno che osasse definirla un David Byrne in gonnella, la polistrumentista lesbica St. Vincent (al secolo Annie Erin Clark: St. Vincent è uno pseudonimo scelto in onore del poeta Dylan Thomas, il nome dell’ospedale dove il bardo gallese morì nel 1953) farebbe, come minimo, un occhio nero. E non avrebbe torto: con Byrne la geniale musicista di Tulsa si è misurata da pari a pari nell’ottimo album precedente a quello in questione e l’accostamento sarebbe, per quanto non improprio, di sicuro irriverente. Certo di Byrne la muscolare fanciulla ha alcuni aspetti caratteristici sia fisici (l’eleganza sinuosa per esempio, ma lei è molto più carina…), sia creativi (l’eclettismo, l’imprevedibilità), sia propriamente musicali (un incedere a scatti, un ricorrente uptempo tutto di nervi). Questo suo quarto disco in studio ha un gran tiro, diciamolo subito e si è meritatamente aggiudicato una sequela di premi da parte di critica e pubblico. Prodotto da John Congleton, si avvale della collaborazione di Homer Steinweiss, batterista di Sharon Jones and The Dap-Kings e di McKenzie Smith dei Midlake. Con uno spettro d’ispirazione che spazia da Stravinskij, all’hip hop, ai Nirvana, il funk-art-pop di St. Vincent non manca di omaggiare anche i Talking Heads con il brano di apertura Rattlesnake, dove l’incalzante altalenare dei synth sottolinea la disavventura di una ragazza inseguita da un serpente a sonagli, e ancor più esplicitamente con il secondo altrettanto adrenalinico pezzo, Birth in Reverse, o nel sinuoso quasi bolero Huey Newton, dedicato al defunto fondatore delle Pantere Nere, o in Psychopath che non può non riecheggiare, se non altro per l’argomento, l’indimenticabile Psychokiller; non mancano i pezzi melodici e lenti come la sensuale Prince Johnny o la ballata romantica I Prefer Your Love, dedicata alla madre (mi piace da morire il ritornello: “But all the good in me is because of you /It’s true/I, I prefer your love/To Jesus”), o l’orecchiabilissima eppure mai scontata Severed Crossed Fingers e le gradevolmente retrò anni ’80 Regret e Every Tear Disappears; la massima dose di funky è raggiunta poi in Digital Witness e soprattutto nell’indiavolata Bring Me Your Loves. Un gran disco.
11) Peter Hammill & Gary Lucas, Other World, 2014
Che avranno mai a che spartire fra loro Peter Hammill e Gary Lucas ? Il primo, introverso e talvolta solipsistico ex-leader dei Van Der Graaf Generator, unica icona del brit–prog ad essere sempre stata profondamente amata anche nell’ambiente dell’heavy metal e rispettata perfino dai punk (Johnny Rotten dichiarò più volte che senza l’hammilliano Nadir’s Big Chance del 1975, non ci sarebbero mai stati i Sex Pistols…); il secondo, geniale chitarrista statunitense scaturito dal blues e dalla psichedelia, membro fin dagli inizi della Magic Band del grande Don Van Vliet alias Captain Beefheart, e poi, in un florilegio di nomi, collaboratore di Lou Reed, John Cale, Jeff Buckley, Nick Cave, Iggy Pop, John Zorn, Patti Smith, fino al liutista olandese Jozef Van Wissem. La risposta alla domanda iniziale è: molto più di quello che immaginiamo. L’art-rock colto, profondamente europeo, da sempre schizofrenicamente scisso e dilacerato fra celestiali melodie e cacofonie infernali, di Hammill e l’eterogenea e fantasiosa koiné di sound americano – blues, ballad, country, jazz – di Lucas, si sposano magnificamente: il disco riserva piacevolissime sorprese. La voce è quella di Hammill, ovviamente, ma entrambi i musicisti suonano le chitarre e le tastiere elettroniche. Si parte con la breve e irresistibile Spinning Coin, un vero gioiellino, la tipica ballata dell’Hammill melodico, malinconico ed esistenzialista alla massima tensione: il testo, breve e, come sempre, significativo, vale la pena tradurlo: ” ’Guarda – disse lei – C’è qualcun altro.’ /Molto tempo fa e molto lontano,/ non sapevo bene come atteggiarmi e cosa dire. / La vita avrebbe potuto essere diversa / se fossi stato eloquente quel giorno/ ma non ho trovato parole coerenti / e me ne sono andato./ Nelle piccole cose ci accorgiamo/ che tutti i puntini di sospensione dell’esistenza sono uniti/ dai risultati casuali / del testa e croce di una moneta”. Con Some Kind of Fracas, ecco mostrarsi subito l’altra faccia: rumorismo, chitarre distorte, voce monologante; segue Of Kith and Kin, che ci riporta alle atmosfere melodiche e dolcemente depresse della prima canzone; poi due strumentali Built from Scratch and Attar of Roses, il primo atonale e minimalista con feedback e armonici dissonanti, il secondo ancora più astratto con suoni d’acqua e un tocco di flamenco: proprio queste parti strumentali, per quanto suggestive in certi punti, ci riportano ad uno sperimentalismo elettronico che suona un po’ ingenuo e datato: non sarà certo lo sfrigolare di un sintetizzatore a stupire l’ascoltatore come poteva ancora avvenire negli anni ’70 (anche il quasi coetaneo Franco Battiato cade in analoghi vezzi nel suo ultimo lavoro: Joe Patti’s Experimental Group… ma sperimentale forse qui è inteso in senso ironico…). A questa stessa categoria, ma con una più matura compiutezza, appartengono anche gli altri strumentali del disco, il breve Means to End e il conclusivo Slippery Slope; ottimi esempi di avant-pop sospesi fra blues, folk e prog, con spiazzanti détournement di chitarre finger-picking, i rimanenti pezzi: Cash; This Is Showbiz; The Kid; Glass, 2 Views, Reboot. Davvero un “altro mondo” per l’isolato cantautore britannico, così scevro da qualsiasi compromesso con lo Showbiz da rasentare l’ascetismo: finalmente, però, un mondo abitabile…