di Walter Catalano
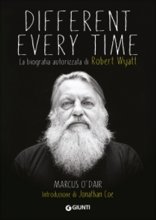 Marcus O’Dair, Different every time: La biografia autorizzata di Robert Wyatt, Giunti, 2015, pp. 448, € 29,00
Marcus O’Dair, Different every time: La biografia autorizzata di Robert Wyatt, Giunti, 2015, pp. 448, € 29,00
Come si fa a non amare Robert Wyatt? L’instancabile generatore percussivo di tempi dispari dei primi, indimenticabili, Soft Machine; il bardo di Canterbury, trickster patafisico innamorato delle avanguardie; lo scatter irrefrenabile dalla voce fragile e sinuosa come una cornetta col wah-wah, perennemente irrisolto fra la melodia della forma canzone e l’atonalità dell’improvvisazione free jazz dei Matching Mole; il nomade, il vagabondo inarrestabile immobilizzato su una sedia a rotelle, come una farfalla impalata a uno spillo per entomologi, già prima del trentesimo compleanno; il marxista non pentito e il granitico militante comunista: inattuale, terzomondista, filosovietico fino a rischiare l’accusa di stalinismo, sempre pronto a mettersi generosamente al servizio della causa e a prendersene la responsabilità; il geniale autore di canzoni uniche e diverse da qualsiasi altra – Sea Song, Alifib, Chairman Mao, Alliance, Free Will and Testament, ecc. ecc. – o il prodigo interprete al servizio di brani non suoi, capace di sublimare una canzone – I Am A Beliver, Shipbuilding, Biko, Te Recuerdo Amanda, Strange Fruit, Yolanda, ecc. ecc. – rendendola più autentica, più umana, più commovente, di essenzializzarla scavandovi dentro nel profondo fino a svelarne nuovi significati e risonanze. Ogni volta diverso, Robert, è impossibile non amarlo.
Finalmente l’amore, condiviso da migliaia di appassionati, per questo gigante della musica e della cultura britannica ha trovato espressione in uno splendido libro biografico di quasi 450 pagine, Different Every Time (titolo tratto dal verso iniziale di Sea Song, una delle canzoni d’amore meno convenzionali e più toccanti mai scritte: “Sembri diversa ogni volta che emergi dall’acqua marina/ con la pelle che brilla dolcemente alla luna/ in parte pesce, in parte focena, in parte capodoglio bambino/ Sono tuo ? Sei mia per giocare insieme ?” …Chi mai avrebbe l’ardire, in un contesto romantico, di paragonare la propria bella a un pesce o a un cetaceo ? Solo Robert, e: “La tua pazzia si intona perfettamente alla mia, la tua stranezza è proprio sintonica alla mia: noi non siamo soli” – conclude). Opera del noto programmista BBC e giornalista musicale Marcus O’Dair, la “biografia autorizzata” è stata pubblicata in Inghilterra circa un anno fa, in parallelo con un doppio cd antologico che ne condivide titolo e foto di copertina, e viene ora – con ammirevole prontezza e senso dell’opportunità – tradotto nella nostra lingua da Giunti. Il volume – bello esteticamente, pieno di foto e di immagini in bianco e nero prestate dagli archivi privati della famiglia Wyatt/Ellidge; maniacalmente dettagliato di discografie, bibliografie, video-filmografie, sitografie, ecc. oltre che appassionante e piacevolissimo alla lettura – è diviso, come anche il cd musicale, in due sezioni: “Bipede batterista” e “Ex Machina”, vale a dire due fasi ben distinte, separate dalla grande cesura nella vita di Robert, il prima e il dopo del terribile incidente che nel 1973 lo privò per sempre dell’uso delle gambe: cesura che segna il suo passaggio – come la ricerca biografica sottolinea e conferma – dall’adolescenza alla maturità di musicista e di uomo.
Rampollo di una famiglia della media borghesia colta – giornalisti e scrittori, un nonno noto architetto, open minded e di solide tradizioni fabiane e socialiste – Robert frequenta – con scarso profitto – la Grammar School (il corrispettivo del nostro Liceo classico, una scuola borghese e tradizionalista: si consideri che i grandi del rock britannico, a cominciare da John Lennon, vengono tutti quanti dall’Art School, il corrispettivo del nostro Liceo artistico) che abbandona molto presto, deludendo i genitori. Conosce però diversi “primi della classe”, studenti tipici della Grammar School con un po’ di puzza sotto il naso, che seguono il jazz e le avanguardie, e vogliono fare musica ma non accontentandosi delle canzonette in 4/4. Mike Ratledge e Hugh Hopper – metà cervellotica e sofisticata dei futuri Soft Machine – vengono fuori proprio da lì. Robert comincia – com’è tradizione di ogni batterista di rispetto – con le pentole ma passa presto a qualcosa di più sofisticato e sperimenta vari altri strumenti, soprattutto a tastiera, con l’aiuto del padre George Ellidge, jazzista dilettante. Nel frattempo la casa è diventata un porto di mare in cui convivono fratelli e fratellastri di precedenti matrimoni (per esempio Mark Ellidge, divenuto in seguito famoso attore: un ruolo a caso, il Pycelle di The Game of Thrones), amici e pensionanti (uno di questi sarà il girovago hipster Daevid Allen, anima patafisica dei primissimi Soft Machine e in seguito fondatore dei Gong). Mentre il padre si ammala di sclerosi multipla e – amara ironia della sorte – passa gli ultimi anni in sedia a rotelle (“Ora che lo so per esperienza diretta – commenta il musicista – rimpiango di non averlo portato a passeggio più spesso”), Robert, avvalendosi delle ampie relazioni nell’ambiente artistico-intellettuale della famiglia, si concede viaggi d’istruzione a Parigi – un giorno intero in visita allo studio dell’ormai anziano Georges Braque, il suo pittore preferito – e lunghe estati ospite a Deià, in Spagna, alla corte del grande poeta e scrittore Robert Graves, intimo amico della madre, dove approfondisce, tra l’altro, lo studio delle percussioni.
Da tutte queste fruttifere esperienze giovanili emerge prima il complesso, entusiasta ma ancora dilettantesco, dei Wilde Flowers e poi quello, già insospettabilmente maturo, dei Soft Machine (nome ispirato al titolo del romanzo di William Burroughs, in realtà ben poco intonato all’estetica del gruppo: lo scrittore interpellato a Londra dai giovani componenti della band concede comunque bonariamente il suo permesso all’uso della citazione). La prima esperienza musicale da professionisti, vede all’inizio l’estroverso e funambolico Robert alla batteria e alla seconda voce, l’occhialuto e timido Mike Ratledge alle tastiere, il delirante seguace di Alfred Jarry Daevid Allen alla chitarra e il bel tenebroso Kevin Ayers, tombeur de femmes dalla voce baritonale che ben duetta con i falsetti di Wyatt, alla chitarra e al basso. Il gruppo esordisce nella mecca underground londinese dell’epoca: l’UFO, dove condivide il palcoscenico con i Pink Floyd, che diventano amici fraterni e sodali indefessi nel light-show psichedelico dello sballo generale. Più ostici musicalmente ma tecnicamente assai più bravi dei colleghi Floyd, i Soft avranno l’onore di accompagnare in ben due tournèe statunitensi niente meno che Jimi Hendrix con gli Experience. Perdono nel frattempo per strada prima Allen, esule in Francia, e, poco dopo anche Ayers; il dilemma in cui il gruppo si è eternamente dibattuto fin dalle origini è quello della scelta, mai risolta nei primi due album, fra forma canzone melodica e free-form improvvisata: Kevin, geniale cantautore ma scarso improvvisatore e digiuno di jazz, non regge la perizia tecnica degli altri componenti e molla, avviandosi ad una ingiustamente sottovalutata carriera solista (dalle file del suo nuovo gruppo emergerà il giovane genio polistrumentista Mike Oldfield che di lì a poco sfornerà il suo best seller Tubular Bells). Robert resta a metà strada: tecnicamente al pari con gli altri, ma deciso ad essere, oltre che un batterista, un cantante, viene messo in minoranza. Ratledge, sostenuto dai nuovi membri, il vecchio compagno di scuola Hugh Hopper, subentrato al basso, ed Elton Dean, ai fiati, dopo l’exploit di Moon in June – prima grande composizione wyattiana sul Third – silenziano il percussionista imponendogli brani solo strumentali e lo isolano sempre più in attesa, poco cavallerescamente, di trovare l’occasione per sbatterlo fuori.
Robert esce malconcio dall’esperienza: autostima sotto zero, incubi ricorrenti, depressione, alcolismo cronico. In quegli anni divorzia dalla prima moglie Pam, da cui ha avuto il figlio Sam (e probabilmente anche la seconda figlia di lei, Alice), collabora con i vecchi compagni patafisici Daevid Allen e il suo nuovo gruppo, i Gong, e Kevin Ayers; diventa uno dei tre batteristi fra i 47 membri dei Centipede – il mega ensemble jazz in cui militano anche Keith Tippett e Robert Fripp – e – mentre si trova una nuova fidanzata, la bella suffragette della ormai non più swinging London, Caroline Coon, giornalista femminista che lancerà in seguito i Clash – incide l’estremistico esperimento free-rock, The End of an Ear, in cui guardando a Picasso e Chagall, dà dei punti perfino agli spocchiosi compagni della Morbida Macchina, che fiancheggia ancora, con scarsa partecipazione, nel loro album Forth, ormai lontano mille miglia dalle sue corde, prima di essere sgarbatamente e definitivamente licenziato.
A questo punto Robert, sempre tendente alla depressione, entra davvero in crisi: beve come una spugna facendo naufragare nell’alcool il già tormentato rapporto con Caroline (ne resta traccia nell’autobiografica O Caroline, di cui scrive il testo ma non la musica, sul primo LP dei Matching Mole: “David è al piano e io me ne sto alla batteria, cerchiamo di far funzionare la musica e cerchiamo di divertirci. Ma non posso fare a meno di pensare che se tu fossi qui con me, i miei pensieri non sarebbero sfocati e suonerei molto meglio: ti amo ancora Caroline. Ti voglio ancora Caroline. Ho ancora bisogno di te Caroline. E se chiami tutto questo solo merda sentimentale, allora mi fai andare proprio fuori di testa, perché lo sai che non canterei mai di una fissazione passeggera. E se i miei tentativi di rima non convincono il tuo orecchio, vuol dire che i ricordi ti tradiscono con il passare del tempo. Ti amo ancora Caroline…”). Abbandonato dai vecchi compagni del gruppo che aveva fondato e dalla donna che lo aveva consolato nei momenti difficili, Robert tenta platealmente il suicidio per la seconda volta (la prima era stata da ragazzo, per l’incapacità di fronteggiare le sue inadeguatezze scolastiche con i genitori): si taglia le vene nella vasca da bagno. Recuperato per un soffio e rimesso in sesto, Wyatt si distrae flirtando con i sodali di Canterbury, i Caravan e i futuri Hatfield and the North, con i transfughi dei quali fonda un suo gruppo, i Matching Mole (il nome in francese assuona con Machine Molle: ancora Soft Machine, la Francia è il paese più fedele alla sua ex band che continua ad ossessionarlo…). Due grandi dischi, di nuovo indecisi fra melodia (O Caroline, Signed Curtain, God Song) e atonalità free: il dilemma ancora non risolto persiste. Il secondo dei due, Little Red Record, ostenta fin dalla copertina un’iconografia maoista che anticipa, per il momento ancora più che altro per gioco, le imminenti posizioni politiche del musicista (che però saranno marxiste e comuniste ma mai esattamente maoiste…). In questo periodo Robert incontra anche Alfreda Benge, detta Alfie, ex fidanzata di Pip Pyle, batterista dei Gong e degli Hatfield and the North, secondo marito della sua ex moglie, Pam, e patrigno dei suoi figli: un curioso scambio di coppia. Sarà Alfie la compagna della sua vita, moglie a tutt’oggi, agente, autrice di molti dei suoi testi più recenti e di tutte le copertine dei suoi dischi, da Rock Bottom in poi: artista intelligente e donna di forte carattere, che svolgerà per lui una funzione salvifica analoga a quella di Kathleen Brennan nei confronti di Tom Waits, cercherà – non sempre con successo – di allontanarlo dalla bottiglia, e lo terrà sempre saldo, anche dietro una sedia a rotelle.
Nel 1972 Robert scioglie i Matching Mole, insoddisfatto della sua veste di leader e front-man nella quale si sente fuori ruolo e, progettando un nuovo gruppo insieme a Francis Monkman appena uscito dai Curved Air; si riposa poi a Venezia dove Alfie è coinvolta nella produzione di Don’t Look Now (A Venezia un dicembre rosso shocking) film di Nicholas Roeg con protagonista la grandissima amica della coppia, Julie Christie (divertente l’affermazione univoca dei membri dei Matching Mole intervistati sulle frequenti visite dell’attrice in sala di registrazione, dove l’affascinante Julie partecipa in incognito ai cori di Little Red Record: “Non c’era verso di concentrarsi sulla musica. Almeno fosse stata una stronza ! …Ma no, era pure simpatica, gentile, adorabile… come si faceva a non innamorarsi perdutamente di lei ?”). Al ritorno dall’Italia Wyatt è invitato a un mega party a Londra e, ubriaco fradicio (ma non sotto l’effetto dell’LSD, come qualcuno ipotizzò: Robert ha avuto vari problemi con l’alcool ma non ha mai fatto uso di droghe), precipita dal quarto piano spezzandosi la spina dorsale.
Non morì proprio perché era ubriaco fradicio: il corpo restò rilassato durante la caduta e Wyatt atterrò sui talloni fratturandosi la dodicesima vertebra toracica con irreparabili danni al midollo spinale. A ventotto anni restò paralizzato dalla vita in giù. Il musicista è tuttora contraddittorio sui motivi del tragico incidente: potrebbe essersi trattato di un terzo tentativo di suicidio, il fantasma inesorcizzabile del suo fallimento con i Soft Machine, del suo ingiustificato senso di inferiorità come musicista; oppure di una maldestra fuga, calandosi giù per la grondaia, dalla vergogna di essere colto in flagrante in una “situazione imbarazzante”, facilmente immaginabile durante una festa di quel tipo. Risultato: dopo sette mesi di ospedale Robert torna a casa paraplegico, “con probabilmente dieci anni in meno di vita – gli dice un medico – venti, se fuma”. Non potrà mai più suonare la batteria, almeno non quella classica con grancassa e charleston, ma dovrà limitarsi alle tastiere e al canto: paradossalmente, per la prima volta si sente davvero un musicista libero.
Amorevolmente accudito da Alfreda, Robert sopporta con stoicismo i postumi della dimissione dall’ospedale, cercando di accettare la sua nuova condizione e di convivere con essa. Le difficoltà economiche vengono temporaneamente risolte dalla generosità degli amici: i Pink Floyd gli devolvono gli incassi di due concerti in suo onore – circa diecimila sterline – con i Soft Machine come supporter, e Julie Christie regala alla coppia addirittura un appartamento a Twickenham, sobborgo alla periferia sud-occidentale di Londra.
Il matrimonio fra Robert e Alfie e l’uscita dell’indiscusso capolavoro Rock Bottom sono contemporanei: già il disegno in copertina (la prima delle molte realizzate da Alfie per i dischi del marito) tratteggia la visione di un mondo sommerso e la musica – composta in larga parte su un organo quasi giocattolo di fabbricazione italiana, un Riviera, che imprime un sound inconfondibile all’opera – evoca lo scorrere dell’acqua, la deriva delle correnti, il flusso e il riflusso delle maree, ispiratogli dalla permanenza veneziana, precedente all’incidente, durante la quale aveva concepito gran parte dei pezzi. Abbiamo già ricordato l’immortale Sea Song ma dobbiamo citare ancora almeno Alifib e Alife, titoli in cui il nome della persona amata diventa scioglilingua e calembour, frammento di una storia d’amore fatta anche di passione, di humour e di malinconia ma del tutto priva di stucchevoli sentimentalismi (Robert canta non “Alife, my lover” come potrebbe sembrare a un orecchio distratto, ma “Alife, my larder”, “Alife, mia dispensa” e la voce di Alfie, sovraincisa risponde: “Non sono la tua dispensa,/ vasetti appiccicosi e senape./ Non sono la tua cena,/ dico a te, vecchia e sdolcinata crema inglese”; poi il battibecco fra amanti si scioglie in filastrocca nonsense e balbettamento infantile o dadaista: “Not nit not nit no not/Nit nit folly bololy/Burlybunch, the water mole/Hellyplop and fingerhole/Not a wossit bundy, see?/For jangle and bojangle/Trip trip/Pip pippy pippy pip pip landerim”… genio allo stato puro).
Negli anni immediatamente seguenti Robert attraverserà le glorie della ribalta, con l’epico concerto al Drury Lane, l’8 settembre 1974, per approdare infine all’idiosincrasia fobica per i palcoscenici che lo ha tenuto lontano fino ad oggi – salvo occasionali e tormentate eccezioni – dalle esibizioni dal vivo; e passerà dalla rilettura di “canzoncine” volutamente e solo apparentemente leggere, come l’hit dei Monkees I am A Beliver – che lo porterà imprevedibilmente al Top of the Pops – alla esternazione militante di dischi profondamente politici come Ruth is Stranger Than Richard (con cover come Song For Che di Charlie Haden) che lo allontaneranno per qualche anno dal grande pubblico facendolo ripiombare nella depressione e nell’alcolismo.
Al principio degli anni ’80, in piena era Thacher, Robert per reazione si iscrive al CPGB, il partito comunista britannico, su posizioni decisamente filosovietiche, commentando: “quando penso che gli anticomunisti sono Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet, Nixon, Thacher, Botha, mi dico che allora i comunisti devono per forza aver fatto qualcosa di buono”. Si dedica poi ad una serie di 45 giri per l’etichetta militante Rough Trade, che confluiranno in seguito nella raccolta Nothing Can Stop Us, dove rilegge classici della canzone politica latinoamericana come la cilena Arauco di Violeta Parra o la cubana Caimanera di Carlos Puebla; dell’antirazzismo statunitense come Strange Fruit, cavallo di battaglia di Billie Holiday, o At Last I Am Free degli Chic, band eponima della disco nera, che Wyatt esalta in chiave rivoluzionaria; di brani provocatoriamente filostalinisti come Stalin Wasn’t Stallin’ o il poema Stalingrad; o terzomondisti come Trade Union, folk sindacalista bengalese affidato ad un gruppo di richiedenti asilo politico che inquadra nella band Dishari, in modo da assicurare loro, con un’incisione professionale, il rango di musicisti professionisti che li legittimi agli occhi severi del Ministero degli Interni inglese; aggiungerà in seguito Red Flag (inno del sindacalismo britannico sulle note di Tannenbaum), L’Internazionale, e l’unica sua composizione originale, Born Again Cretin, spietata parodia degli intellettuali liberals.
Altro pezzo straordinario del 1982 per la Rough Trade è Shipbuilding, la cui interpretazione commosse fino alle lacrime i due autori della canzone (Elvis Costello, testo, e Clive Langer, musica, che l’avevano scritta apposta per Robert): la chiave di lettura – quanto di più marxista e antithacheriano si potesse concepire – è il conflitto fra la disoccupazione operaia nei cantieri navali del nord dell’Inghilterra e la ripresa dell’indotto apportata dalla guerra delle Falklands (“Ne vale la pena?/Un cappotto nuovo e scarpe per la moglie/E una bicicletta per il compleanno del ragazzo. /È soltanto una voce che gira per la città/Tra le donne e i bambini, che presto inizieremo le costruzioni navali. /Beh, lo chiedo a voi: /Il ragazzo ha detto: /“Papà, mi faranno arruolare,/ Ma sarò a casa per Natale.” /È soltanto una voce che gira per la città: /so che qualcuno è stato aggredito/ per aver detto che c’è gente che resta ammazzata/ a causa della loro costruzioni navali. /Con tutta la volontà del mondo /Ci tuffiamo per poter sopravvivere /Quando potremmo tuffarci in cerca di perle. /È soltanto una voce che gira per la città /Un telegramma o una cartolina illustrata: /Nel giro di qualche settimana riapriranno il cantiere navale /E daranno l’annuncio ai parenti più prossimi/Ancora una volta. /È l’unica cosa che sappiamo fare: presto costruiremo navi. /Con tutta la volontà del mondo /Ci tuffiamo per poter sopravvivere /Quando potremmo tuffarci in cerca di perle”.)
Un’altra verità che Wyatt ci insegna in quegli anni è il fatto che una canzone politica non debba necessariamente essere una canzone triste: Robert ce lo dimostra con The Wind of Change – incisa con gli SWAPO Singers, gruppo della Namibia impegnato contro l’aparthaid e il razzismo – vero e proprio inno che si unisce a Free Nelson Mandela degli Specials o a Venceremos dei Working Week (ancora con Wyatt), a connotare il sound Ska ideologizzato che segna tutta un’epoca (almeno per chi, come me, non ascoltava altro allora…). “The Wind of Change is sweeping across the African Continent…”.
Dopo questa lunghissima parentesi come puro interprete Wyatt torna alla composizione con due LP in solitaria cioè incisi da solo suonando tutti gli strumenti, senza alcuna collaborazione di altri musicisti: Old Rottenhat del 1985 e Dondestan del 1991, due dischi fortemente politici dove figurano alcune delle sue canzoni più incisive da questo punto di vista, anche se forse non del tutto rifinite sul piano musicale, a causa di un eccesso di arrangiamenti solipsistici e di missaggi spartani: citiamo nel primo, Alliance, in cui si denuncia lo spostamento a destra del partito laburista; The Age of Self, in cui si evidenziano le divisioni interne alla sinistra; The United States of Amnesia, in cui si rinfaccia agli USA di aver costruito un “impero ariano” sterminando “tutti quei pellirosse”; nel secondo Left on Man, in cui si ribadisce “Pentagon über alles”; CP Jeebies, in cui si dice addio al CPGB ormai in balia del New Labour; N.I.O. (New Information Order) in cui si sfotte aspramente il partito conservatore per la sua mania della privatizzazione. In Dondestan i testi sono, per la prima volta, quasi interamente opera di Alfreda.
La parte conclusiva del libro esamina i capolavori più recenti Shleep (1997), Cuckooland (2003), Comicopera (2007) e …For the Ghosts Within (2010) oltre che tutte le numerose collaborazioni degli ultimi anni e i suoi successi come occasionale commentatore politico televisivo (molto radicale, ovviamente, ma alla BBC si può…) e organizzatore di prestigiosi festival culturali come il Meltdown. In questi dischi più tardi, Robert ha finalmente potuto lavorare con calma e sicurezza di mezzi, contando su uno studio di registrazione messogli a disposizione dall’amico Phil Manzanera – ex chitarrista dei Roxy Music – e sull’appoggio di un gran numero di altri amici musicisti a fiancheggiarlo: tra i molti, Manzanera stesso, Paul Weller, David Gilmour, alle chitarre; Brian Eno, all’elettronica; Annie Whitehead, al trombone; Giliad Atzmon, ai sax, clarinetto e flauto; Karen Mantler (figlia dei jazzisti Carla Bley e Mike Mantler), alle tastiere e voce; Ros Stephen e il Sigamos String Quartet, agli archi; ecc. ecc. Robert suona un po’ di tutto, anche la tromba e la cornetta che da sempre aveva imitato con la voce e consegna ai posteri una musica sofisticata e autentica, sempre godibile ma mai scontata: che siano cover coraggiose nella loro apparente ovvietà (chi oserebbe riproporre Hasta siempre, Comandante, senza il rischio di evocare l’entusiasmo etilico a una cena di compagni; What A Wonderful World, In A Sentimental Mood, o ‘Round Midnight senza quello di sollevare l’accusa di banalità e dilettantismo jazzofilo da filarmonica di provincia ?) oppure brani originali di grande impatto e suggestione. Ricordiamo almeno la stoica e sublime Free Will and Testament (“Mi è dato il libero arbitrio ma entro limiti ben definiti./Non posso volere per me stesso cambiamenti senza fine./ Non posso sapere cosa sarei se non fossi me./ Posso solo immaginarmi./ Così se dico che mi conosco, come posso saperlo ?/Quale ragno comprenderebbe l’aracnofobia ?/ Ho i miei sensi e il mio senso di avere dei sensi./ Io guido loro o loro guidano me ?/ Il peso della polvere supera quello degli oggetti in riposo./ Che senso ha la gravità se non c’è un centro ? / Esiste libertà di non-essere ?/ Esiste libertà dal voler essere ? / Il puro impulso ci fa agire in questo modo o in quello./ Poi tiriamo a indovinare o ci inventiamo una giustificazione. / Vorrei disperdermi, essere disconnesso. E’ possibile ?/ A che servono soldati senza un nemico ?/ Essere nell’aria ma non essere aria, esistere nell’assenza di aria. / Essere sciolto, né compresso, né sospeso. / Né nato, né lasciato morire. / Fossi stato libero avrei potuto scegliere di non essere me ? / Forze dementi mi costringono a far girare la ruota di un mulino/ Lasciatemi fuori, per piacere. Sono così stanco./ Lasciatemi fuori, per piacere. Sono davvero molto stanco.”); l’elegiaca Was A Friend, riconciliazione dopo gli antichi dissapori, con Hugh Hopper, l’amico-nemico che lo volle fuori dai Soft Machine (“Le vecchie ferite stanno guarendo. / Le cicatrici sbiadite non dolgono – solo un po’ di prurito”); l’esuberante Blues in Bob Minor, omaggio citazionistico alla Subterranean Homesick Blues di Bob Dylan; la polemica Foreign Accent, che ripete ossessivamente lo slogan mediatico angloamericano degli anni in cui si voleva giustificare l’attacco all’Iraq: “Distruzione di massa”; A Beautiful War che irride alla “bombe intelligenti” e Out of the Blue che considera gli effetti di quelle bombe: “…hai piantato nel mio cuore il tuo odio imperituro”.
Robert Wyatt annuncia nelle ultime pagine del testo il suo ritiro artistico per raggiunti limiti di età e perché, dice, “ormai la politica mi interessa più della musica”; ma “il Chet Baker britannico”, così qualcuno lo ha definito, non può giocarci questo brutto tiro: “Tra i musicisti della sua generazione – ha detto di lui Jerry Dammers – lo colloco nella stessa categoria dei Nick Drake, Syd Barrett e Peter Green, con la differenza che lui è vivo”. E fin che c’è vita c’è speranza: noi restiamo in fiduciosa attesa del prossimo disco che sicuramente verrà (già altre volte Robert ci ha fatto preoccupare…). Intanto ci consoliamo leggendo questo splendido libro e – come dice acutamente Jonathan Coe nell’introduzione – riascoltando senza sosta le sue “canzoni savie per tempi folli”.



