di Manolo Morlacchi
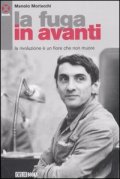 Manolo Morlacchi, La fuga in avanti. La rivoluzione è un fiore che non muore, ed. Agenzia X, pp. 216, € 15,00.
Manolo Morlacchi, La fuga in avanti. La rivoluzione è un fiore che non muore, ed. Agenzia X, pp. 216, € 15,00.
La fuga in avanti è uscito nelle librerie da qualche settimana e ci sono alcune osservazioni, provocazioni, domande, che appaiono in modo ricorrente nelle presentazioni a cui partecipo e nelle recensioni che ho potuto sin qui leggere, in particolare, la segnalazione di Wu Ming 1 su Nandropausa. Quindi mi sono convinto della necessità di approfondire alcune questioni intorno al mio libro.
Lungo le pagine de La fuga in avanti descrivo a più riprese con grande enfasi e nostalgia il clima in cui ho trascorso gli anni della mia infanzia e adolescenza, suppergiù dal 1975 al 1985. Questa descrizione può sollevare qualche fastidio o perplessità tra chi ha vissuto in prima fila quella stagione politica e ne ha pagato duramente le conseguenze. Ma la mia lettura è volutamente provocatoria. E’ il tentativo di porre in relazione tra loro i profili umani e sociali di chi decise di andare allo scontro con lo Stato, rispetto ai profili umani e sociali con cui siamo abituati a convivere oggi. E’ il tentativo di dimostrare come, in ultimo, quei nomi e cognomi siano gli stessi di allora; che non si tratta di biografie personali, ma di vicende collettive, di opportunità politiche e rivoluzionarie, di questioni molto materiali. E’ il tentativo di intervenire sulla vulgata comune, secondo la quale gli anni ’70 sono stati un medioevo contemporaneo, plumbeo e segnato dall’ultraideologia.
I miei ricordi mi descrivono una realtà diversa. Nel mio quartiere, il Giambellino, negli anni ’70, i proletari erano dalla parte delle Brigate Rosse. Tante sono le testimonianze a riguardo. Tutti sapevano chi fossero i clandestini; capitava che gli stessi clandestini te li ritrovavi a cenare o a bere nelle trattorie e nei luoghi di ritrovo del Giambellino, alla Bersagliera o alla Cooperativa, senza che nessuno avesse qualcosa da ridire (e non si trattava di paura). In Piazza Tirana le BR tennero alcuni comizi pubblici senza che la polizia intervenisse. Sui tetti delle case popolari spesso comparivano bandiere rosse con la stella a cinque punte. Gli stessi militanti del PCI sapevano chi si nascondeva dietro le Brigate Rosse, ma nella peggiore delle ipotesi ci convivevano. Mio padre era così legato alla sua storia nel partito che, negli ultimi anni della sua vita, si iscrisse a Rifondazione Comunista e festeggiò la prima vittoria di Prodi su Berlusconi!
Chi scrive non intende certo separare la storia delle Brigate Rosse avventuriere e romantiche, rispetto alla storia delle Brigate Rosse sanguinarie e militariste. Esiste una sola storia della lotta armata in Italia e mio padre ne fece parte appieno dal 1970 a quando uscì di prigione nel 1986. Rimase impermeabile a ogni tentativo di alleggerire la propria condizione di prigioniero, senza cercare le scorciatoie della dissociazione o l’infamia del pentitismo. Le sue critiche e le sue perplessità sull’Organizzazione le riservò sempre ai compagni con cui condivideva la propria irriducibile avversione al sistema borghese.
Ciò che mosse quei personaggi del Giambellino e i tanti che li seguirono, era una spinta molto materiale che proveniva da lontano e non rappresentava il frutto di una elaborazione da salotto universitario. In loro si riassumevano tante lotte: la Resistenza al nazifascismo, la fame patita durante e dopo la guerra, le lotte operaie nelle fabbriche degli anni ’50, la rottura con il PCI e il sostegno alla Cina, al Vietnam, a Cuba, alle lotte anticolonialiste africane. Infine, il 1968 e la dialettica difficile con gli studenti, “la futura classe dirigente del Paese che intendeva guidare i cortei”.
Fu questa loro coerenza pratica, prima ancora che intellettuale/ideologica, a rendere particolari quei compagni ed esaltante la mia infanzia. Sapevi chi avevi di fronte. Sapevi che quei personaggi li trovavi a giocare a dadi con la malavita alla stazione ferroviaria di San Cristoforo in piazza Tirana, ma quando c’era bisogno di altro su di loro potevi contare senza dubbi.
Queste sensazioni ho cercato di trasferirle nelle pagine del libro, tentando di evitare ogni reticenza. La fuga in avanti è un libro partigiano che intende porre nel solco delle lotte rivoluzionarie del secolo scorso l’esperienza della lotta armata in Italia. Il mio libro non ha alcun intento pacificatorio. E’ il tentativo di capire gli errori e le conquiste di quell’esperienza a uso e consumo di chi continua a credere che la società del profitto sia un abominio contro cui bisogna combattere.
Un altro aspetto che emerge spesso nei dibattiti intorno agli anni ’70, riguarda la questione della legislazione speciale e, più in generale, delle forme che la repressione ha assunto per sconfiggere la lotta armata: reintroduzione della tortura fisica e psicologica per i prigionieri e per le loro famiglie, uso sommerso della pena di morte ecc.
E’ costume di vasta parte della sinistra istituzionale o meno, affrontare quei fatti come se si fosse trattato dell’esito di una follia collettiva cresciuta nell’alveo delle istituzioni democratiche.
Come se quelle scelte repressive fossero un mostro sfuggito di mano a qualcuno e non il prodotto concreto dei metodi attraverso cui gli apparati dello Stato, di qualunque Stato, intervengono quando il dissenso diventa pericoloso. Come se, rispetto a quegli anni, ci fossero oggi possibilità repressive meno malsane rispetto ad allora. Basterebbe leggere lo splendido libro di Emilio Quadrelli Evasione e rivolte per rendersi conto di quanto questo tipo di lettura, nella migliore delle ipotesi, sia ingenuo.
Chi combatte l’imperialismo con le armi in pugno, ieri come oggi, conosce gli strumenti di cui la borghesia si è dotata per difendere i propri interessi. Sono strumenti perfezionati sulla pelle di coloro che hanno combattuto il capitalismo nei cicli rivoluzionari degli ultimi 150 anni. Elaborazioni teoriche uscite dalle centrali del terrore statunitensi, israeliane, francesi, inglesi, italiane e che hanno trovato applicazione pratica negli scenari sudamericani, medio-orientali, africani, indocinesi, nella lotta contro le organizzazioni combattenti europee e di tutto il mondo. Oggi questi vademecum alla repressione trovano la loro consacrazione planetaria e la giusta versatilità per rispondere a ogni esigenza qualitativa e quantitativa. Abbiamo così il caso dell’Irak dove dei contractor/patrioti italiani partono per difendere gli interessi del capitale violentando donne e bambini, e abbiamo invece il caso di Genova 2001 dove la nostra polizia si limita a dare degli avvertimenti a chi pensava che la borghesia di un Paese democratico utilizzasse strumenti diversi rispetto a quelli che riserva alle periferie del mondo.
Cercare di quadrare il cerchio su questi temi intorno a un tavolo e nel consesso delle istituzioni è, per usare un’espressione gentile, velleitario. A meno che non si pensi che esista una dicotomia tra le istituzioni e gli interessi del capitale.
Al mio libro è stato anche rimproverato di non rispettare il dolore delle vittime di quegli anni. Questo non è affatto vero. Rispetto quel dolore, evitando di parlarne. E non è un semplice escamotage, ma la profonda convinzione di non poter in alcun modo entrare in un dolore che non mi appartiene. Penso che il rispetto sia una categoria che talvolta viene evocata dai vincitori quando gli sconfitti non chiedono “scusa”. Ognuno piange i propri morti come meglio gli aggrada. Io ho grande rispetto per il dolore umano provocato dalla violenza, sia essa rivoluzionaria o repressiva. Molto più importante è dire che questo rispetto l’avevano mio padre, mia madre e i tanti loro compagni. Ho citato volutamente nelle pagine de La fuga in avanti un passo di Senza tregua quando il comandante Visone si trova di fronte ai morti di Piazzale Loreto e osserva i volti soddisfatti e sorridenti dei fascisti: “Mi resi conto in quel momento di quale fosse la distanza che mi separava dai miei nemici. Io non avrei mai potuto ridere di fronte al cadavere del mio nemico. Troppo grande era il peso che mi portavo sulle spalle per quelle morti”.
Ho voluto raccontare una storia delle Brigate Rosse senza affossarmi nelle pieghe della Storia Ufficiale. Non mi sono interessato alle diverse fasi e delle diverse anime della lotta armata: propaganda armata, ala militarista, ala movimentista, prima e seconda posizione, pg, pcc, ucc ecc. Non perché si tratti di questioni poco importanti, ma perché non servono a descrivere nel complesso la storia della più importante organizzazione armata italiana.
Così come non serve a nulla tentare di dipingerla (salvo che non si tratti di una rilettura interessata) raccontando i misfatti e le aberrazioni che si verificarono in particolare dalla fine degli anni ’70 ai primi anni ’80. Gli strangolamenti in carcere di militanti che avevano fatto confessioni sotto tortura; gli omicidi per diffondere un volantino, ecc. ecc. La categoria della violenza, letta in termini assoluti, estrapolata ed estremizzata, descriverebbe da sé l’errore della scelta armata. Assume la forma di un artificio intellettuale per mettere tutti d’accordo. Ma dove stava la violenza in quegli anni in Italia? Era il prodotto di un gruppo di pazzi fuggiti da qualche manicomio, o era la risultante dello scontro sociale in atto? Se ponessimo in competizione la violenza rivoluzionaria con quella della repressione, ebbene vincerebbe con grande distacco quella provocata dalla stragi di Stato, dalla tortura legalizzata, dagli omicidi compiuti nelle piazze, nelle carceri, dai massacri perpetrati dall’imperialismo in giro per il mondo. Ma non serve a nulla questa operazione, a meno che, ripeto, non si tratti di un’operazione politica. Ma allora entriamo in un altro campo. E’ come oggi quando ci fanno vedere in ogni dove gli sgozzatori di Al Qaeda, ma si guardano bene da pubblicizzare le “eroiche gesta” dei nostri soldati e mercenari nei bordelli di Kabul, nei villaggi del Kosovo, lungo le strade dell’Irak.
Mio padre e mia madre rimasero sempre critici e distanti rispetto a certe derive legate alla sconfitta che incombeva sull’organizzazione a cui avevano aderito. Distanti anni luce, come racconto anche con testimonianze nel mio libro. Ma tutto questo poco importa nel giudizio complessivo. Oggi le BR non esistono più. Ma la violenza e la repressione aumentano geometricamente. E’ da questo assunto, da ciò che succede oggi, che bisogna ripartire per rileggere quegli episodi.
Di libri sulle BR ne abbiamo a decine. La violenza, letta in modo unilaterale, resta lo strumento principe per descrivere quell’esperienza. Decontestualizzata, astorica, intellettuale, è una lettura che serve unicamente ad accreditare la storia scritta dai vincitori. Io invece ho provato a scriverla dal punto di vista degli sconfitti; sconfitti, ma non arresi.



