di Franco Pezzini
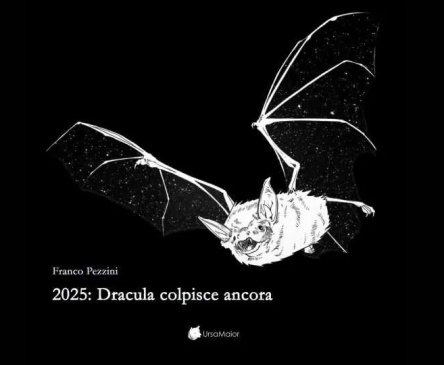 [È comparsa per i tipi UrsaMaior, Pistoia 2025, la raccolta 2025: Dracula colpisce ancora, a cura di chi scrive, con Prefazione di Danilo Arona. Si propone qui l’Introduzione.]
[È comparsa per i tipi UrsaMaior, Pistoia 2025, la raccolta 2025: Dracula colpisce ancora, a cura di chi scrive, con Prefazione di Danilo Arona. Si propone qui l’Introduzione.]
The Picture of Dorian Gray di Oscar Wilde, 1890, non è soltanto un capolavoro letterario in grado d’impattare sull’immaginario collettivo, in un’epoca in cui il ritratto dipinto, dalla borghesia in su, è ancora il modo più comune di celebrare memoria dei propri connotati. In quanto romanzo fantastico, del resto, capitalizza spunti cari fin dalle origini del gotico, quando Walpole attingeva a storie devote e folkloriche proiettando – neanche usasse una lanterna magica – immagini di quadri che si staccano dalla cornice per andarsene a zonzo. Il fatto è che ogni romanzo di successo – e tanto più quando il passo è quello scintillante di un autore come Wilde – muove immaginario, in termini contingenti come di suggestione.
Contingenti: Dorian Gray viene commissionato per l’americano “Lippincott’s Monthly Magazine” dal responsabile Joseph Marshall Stoddart in vista di un’edizione inglese della testata, nel corso dell’indimenticabile cena al Langham Hotel di Londra il 30 agosto 1889 cui partecipa anche Arthur Conan Doyle – che a sua volta viene spinto a scrivere The Sign of the Four, 1890, il secondo romanzo su Holmes. Nella sua autobiografia del 1924, Doyle la definirà golden evening non senza ragione.
Ma l’immaginario viene spesso mosso in termini di suggestione: e un impatto del Dorian Gray è senz’altro riscontrabile nel Dracula di Stoker, 1897. Non solo per quanto riguarda i temi della rifrazione e dell’identità sviluppati nel corso del Dracula che conosciamo, ma in riferimento a precedenti versioni solo progettate o via via superate in quell’ininterrotto cantiere di sette anni di cui restano tracce, lapsus, ombre nella versione definitiva. Dove una sembra direttamente legata al romanzo di Wilde.
Nei primissimi appunti per il Dracula, fortuitamente scoperti e conservati al Rosenbach Museum & Library di Philadelphia, Stoker si sbizzarrisce: tra le caratteristiche del vampiro figura per esempio l’insensibilità alle bellezze della musica (a quel punto capiremo meglio la celebre battuta del Conte sull’ululato dei lupi) o al potere di oggetti sacri più recenti della sua vera età, cioè dell’epoca in cui è storicamente vissuto – il che però limiterebbe parecchio l’efficacia della santabarbara esorcistica degli ammazzavampiri, costretti a procurarsi reliquie dei suoi tempi (quale secolo fosse, precisamente, in questa fase Stoker non pare aver ancora deciso). Simili trovate verranno lasciate cadere con indubbio vantaggio di trama, anche se il loro gusto onirico avrebbe potuto trovare degli estimatori.
Ma altre caratteristiche previste nelle annotazioni ci portano più direttamente in zona-Wilde. Anzitutto il vampiro non si riflette – al castello del Conte, scoprirà Harker, non ci sono specchi – e non proietta ombra, per cui le luci nella sua dimora sono sistemate in modo tale da non smascherare tale caratteristica (“no shadow? / lights arranged to give no shadow”, il romanzo utilizzerà parzialmente lo spunto); ma presenta altri limiti ottici persino più imbarazzanti e surreali. Infatti “Non si può fotografarlo [Could not codak him] – viene fuori nero o come uno scheletro” (in altro appunto si ribadisce la cosa, affermando che “viene fuori come cadavere [plausibilmente nel senso di scheletro] o nero”). Se la prima soluzione trova qualche consonanza col tardo film Hammer I satanici riti di Dracula, Gran Bretagna 1974, dove il Conte non impressiona la pellicola fotografica, le deliziose suggestioni da lanterna magica della seconda richiamano alla mente il penny dreadful attribuito (ma con gravi dubbi) a Elizabeth Grey, The Skeleton Count; or, The Vampire Mistress, 1828, forse prima storia seriale di vampiri nonché presunta prima vampire story scritta da una donna.
Ma a Stoker non basta, l’immagine del vampiro dev’essere irriducibile a qualsiasi forma di rifrazione o ritratto: cioè non può essere fermato neppure con la pittura. Apprendiamo così che i “pittori non possono ritrarlo – their likenesses always like some one else” (Memo 2, Page 4. Rosenbach #38b; una frase del genere è ripetuta a Memo 3, Page 6. Rosenbach #4), nel senso che nonostante ogni sforzo dell’artista, il ritratto non potrebbe effigiare i suoi connotati e il soggetto (a quanto pare dalle note) sembrerebbe sempre qualcun altro.
Il fatto è che Stoker è amico di Wilde, e la soluzione pare ispirata dal Dorian Gray appena edito, con quel quid di macchinosità in più che è proprio dell’autore: ma il tema sembra ronzargli in testa da tanto tempo, visto che un appunto del suo Journal in vista di qualche virtuale narrazione prelude di fatto proprio a questi sviluppi: “Story of man who reflets everybody’s self who meets him” (1° ottobre 1873, n. 57). Non sappiamo come si sarebbe sviluppata tale storia di un uomo – una specie di Zelig? – che riflette il sé di chiunque lo incontri, nuova perversione del rapporto con la rifrazione; e d’altronde la rapidità con cui sono annotati gli appunti del Dracula non permette di conoscere ulteriori dettagli o immaginare il contesto in cui l’autore avrebbe speso le relative suggestioni. Sappiamo però che per drammatizzare il tema del ritratto impossibile, Stoker avesse previsto tra i personaggi anche un pittore, tale Francis Aytown.
Tali caratteristiche non conosceranno in gran parte sviluppi diretti. Ma quanto sappiamo è sufficiente a farvi riconoscere l’estrema deriva di quell’ossessione dell’identità che corre per tutta la letteratura anglosassone (e non solo) dell’Ottocento e si lega a stretto filo con le fantasie sui vampiri: nonché più in generale con la storia della letteratura moderna – che è in fondo tutta letteratura di identità (laica, personale o collettiva), con la narrativa fantastica deputata a illuminarne le crisi e i limiti. E comunque proprio la visualizzazione di un personaggio come il Conte, che nel romanzo non sappiamo neppure se esista – presentato in soggettiva solo per voce dei suoi nemici e oltretutto tutti di discutibile equilibrio mentale – ma compulsivamente portato a teatro e poi sugli schermi (cinema, televisione, videogiochi e quant’altro), per non parlare di una ricca tradizione illustrativa e di fumetto, accede all’idea di un ritrarre Dracula.
Le pagine che seguono mappano una serie di questi ritratti, a partire dal lavoro di Stoker e via via lungo trasposizioni, riletture e reinvenzioni.



