di Sandro Moiso
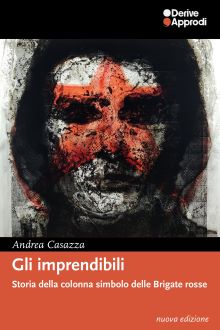 Andrea Casazza, Gli imprendibili. Storia della colonna simbolo delle Brigate Rosse (nuova edizione), DeriveApprodi, Bologna 2025, pp. 500, 28 euro
Andrea Casazza, Gli imprendibili. Storia della colonna simbolo delle Brigate Rosse (nuova edizione), DeriveApprodi, Bologna 2025, pp. 500, 28 euro
Più volte su Carmillaonline chi qui scrive ha avuto occasione di annotare come siano ormai numerosissime le storie e le testimonianze riguardanti l’esperienza della lotta armata condotta in Italia da formazioni di sinistra di vario genere. Annotazione che spesso sono state accompagnate dall’osservazione di come, purtroppo, il fenomeno sia stato più registrato dal punto di vista personale di chi vi aveva partecipato, con tutto il corredo di giustificazionismo pre-politico che ciò poteva comportare, oppure da quello di una lettura tutta istituzionale che, soprattutto nel caso delle Brigate Rosse, ha raggiunto talvolta livelli insopportabili di complottismo e ingiuria politica.
Certo, non mancano gli esempi di opere “serie” che si sono occupate del periodo intercorrente tra la seconda metà degli anni Settanta e la prima degli anni Ottanta nell’ottica della ricostruzione storiografica, e non solo memorialistica o accusatoria, delle vicende delle “bande armate” che raccolsero un gran numero di adesioni e militanti nell’Italia di quegli anni. Come ricorda Pino Casamassima in un suo, non sempre condivisibile, testo pubblicato nel 2012:
Sono stati 20.000 gli inquisiti per i fatti di lotta armata; 4200 sono stati incarcerati a seguito dell’accusa di banda armata o associazione sovversiva; 300 hanno avuto pene con meno di dieci anni, oltre 3100 più di dieci anni, quasi 600 più di quindici anni, centinaia gli ergastoli. Oltre 50000 anni di galera sono stati nel complesso già scontati. Dei 4200, circa 200 (tra cui 40 donne) sono ancora detenuti, parzialmente o totalmente. Tra loro 77 sono ergastolani”1.
Dati da considerare non soltanto di carattere statistico ma, piuttosto, socio-politico; soprattutto se a questi si aggiunge il fatto che è l’identità proletaria, fin dall’infanzia, a caratterizzare molti di coloro che aderirono alla scelta della lotta armata nell’ambito delle BR, a differenza di altre esperienze simili (italiane, europee, americane e giapponesi) che, spesso videro una maggior adesione di studenti, intellettuali e sottoproletari. Mentre, a livello generale, occorre ancora sottolinea che tale scelta, come si vedrà ancora più avanti, coinvolse un gran numero di donne, giovani e giovanissime ma non solo, come dimostrò, ad esempio, il processo contro la colonna Walter Alasia di cui della “sessantina di imputati una quarantina erano donne, cioè oltre la metà”2.
DeriveApprodi, che già ha edito in passato proprio alcuni dei testi migliori sulle origini e la storia della lotta armata3, ripropone una nuova edizione con aggiunta cronologia di un valido testo, già comparso nel 2013, di Andrea Casazza sulla colonna genovese delle BR, definita come la «colonna simbolo» di quell’esperienza.
Simbolica non solo per l’alto numero di azioni portate e a termine, ma anche per il radicamento della stessa nel tessuto sociale del capoluogo ligure e per la storia “particolare” della sua formazione, avendo aggregato, a differenza di altre città come Torino e Milano, militanti provenienti da Lotta continua e, in esigua minoranza, dalla sinistra radicale che si era espressa negli anni precedenti in varie riviste di movimento certamente non di ispirazione marxista-leninista se non addirittura apertamente piccista o stalinista.
Un’esperienza che in qualche modo affondava le sue radici anche nel primo caso di azione armata dell’Italia repubblicana, quella della «banda 22 ottobre»4, un’organizzazione attiva a Genova tra il 1969 e il 1971, che animata da ex partigiani, operai, portuali (alcuni dei quali cresciuti nelle sezioni del Pci) fu tra le prime, se non la prima, insieme ai GAP di Giangiacomo Feltrinelli, a professare e ad attuare forme militari di lotta nel panorama politico italiano.
La ricerca di Casazza, pur essendo quasi del tutto condotta su fonti ufficiali e giornalistiche, si fa leggere come un romanzo di stampo dostoevskiano, per la complessità e la tragicità dei temi che propone, non soltanto politici, ma anche umani. Di cui il massacro dei militanti delle Brigate rosse avvenuto in via Fracchia il 28 marzo 1980 rimane uno dei temi centrali. Centrale sia per comprendere le modalità messe in atto dallo Stato per rimuovere quello che avrebbe potuto diventare, non solo a livello locale, un problema politico e militare piuttosto grave e, soprattutto, la spietatezza con cui tale piano di rimozione e defalcamento di tale impedimento al raggiungimento della pace sociale dopo gli anni delle lotte di fabbrica e di massa doveva essere, e in quel caso fu, portato a termine5.
Un’azione che, affondando le sue origini nella campagna di arresti successiva alla cattura di Patrizio Peci, primo pentito importante della lotta armata italiana, avvenuta a Torino il 20 febbraio 1980 insieme a quella di Rocco Micaletto. Poco più di un mese prima della strage di via Fracchia e a seguito delle rivelazioni rilasciate al generale dei carabinieri Carlo Alberto della Chiesa dallo stesso “Mauro”, nome di battaglia di Peci.
 In quell’appartamento genovese, che probabilmente aveva costituito la base per le riunioni delle BR in città, furono giustiziati Riccardo Dura, Piero Panciarelli, Lorenzo Betassa e Annamaria Ludmann, quest’ultima proprietaria dello stesso alloggio. Sulle modalità operative e gli avvenimenti che accompagnarono l’operazione, fuori e dentro le mura dello stabile è facile comprendere che esistano ricostruzioni quanto meno controverse e contraddittorie soprattutto a causa del fatto che nessuno dei brigatisti presenti fu lasciato in vita per testimoniare la reale successione degli avvenimenti di quella notte.
In quell’appartamento genovese, che probabilmente aveva costituito la base per le riunioni delle BR in città, furono giustiziati Riccardo Dura, Piero Panciarelli, Lorenzo Betassa e Annamaria Ludmann, quest’ultima proprietaria dello stesso alloggio. Sulle modalità operative e gli avvenimenti che accompagnarono l’operazione, fuori e dentro le mura dello stabile è facile comprendere che esistano ricostruzioni quanto meno controverse e contraddittorie soprattutto a causa del fatto che nessuno dei brigatisti presenti fu lasciato in vita per testimoniare la reale successione degli avvenimenti di quella notte.
Al di là delle armi utilizzate, tra le quali il comandante del gruppo operativo vantava la disponibilità di un fucile a pompa in grado di sventrare i muri, già in uso presso la polizia canadese, tutto sembra confondersi, nelle successive testimonianza delle forze dell’ordine e dei dati raccolti dagli inquirenti, nel fumo, nei bagliori e nel frastuono degli spari e nel buio del corridoio una volta sfondata o, aperta con le chiavi ritrovate nelle tasche di Micaletto, la porta dell’appartamento.
Come scrive Casazza nelle sue pagine:
Se il blitz fu messo in atto subito dopo le rivelazioni di Peci, così come si evincerebbe dalla prima nota informativa dei carabinieri alla Procura, o dopo un sia pur frettoloso lavoro di intelligence come sostiene Bozzo6, non è dato sapere. Di fatto, nella notte fra i27 e il 28 marzo, la zona attorno alla palazzina a quattro piani di via Fracchia viene circondata da un ingente spiegamento di carabinieri sistemato a distanza, mentre il blitz viene affidato a un gruppo ristretto del nucleo antiterrorismo. Sono da poco passate le quattro del mattino quando una donna, svegliata dal guaire del suo cane, si alza e si affaccia a una finestra del palazzo: fuori sta piovendo e lungo la stradina in discesa che conduce al portone d’ingresso intravede muoversi delle ombre. Sono carabinieri che, protetti da giubbotti antiproiettile e da caschi, entrano nello stabile e scendono tre rampe di scale per fermarsi davanti alla porta dell’interno 1. Sono in sei e a guidarli è il capitano Michele Riccio. Su quanto avviene da quel momento in poi restano ancora aperti molti interrogativi7.
In contrasto, almeno parziale con il suo braccio destro che avrebbe voluto condurre indagini più stringenti su quell’appartamento di 120 metri quadri e i suoi occupanti, il generale dalla Chiesa aveva fretta di concluder l’operazione. Sia per anticipare possibili altre azioni programmate dai brigatisti sul territorio ligure, sia per poter condurre a termine altre due operazioni simili presso altri “covi” indicati da Peci, a Biella e a Torino.
Secondo la versione ufficiale, peraltro fornita alla magistratura ben otto giorni dopo i fatti, i carabinieri suonano il campanello dell’interno 1, qualificandosi e intimando agli occupanti di aprire. Al che dall’interno, qualche tempo dopo, una voce maschile risponde «un attimo», senza però che la porta venga aperta. Atteso ancora qualche istante e ripetuto l’ordine perentorio di aprire, un militare colpisce la porta con una serie di calci sino a che l’uscio non cede e si spalanca. «I carabinieri potevano così intravedere, al di là di una tenda, un corridoio buio dal quale non proveniva alcun rumore. Intimavano allora agli occupanti la resa e una voce maschile rispondeva: “Va bene, siamo disarmati”. Subito dopo, però, dal fondo del corridoio veniva esploso un colpo di pistola che colpiva al capo il maresciallo Benà. I carabinieri aprivano il fuoco e udivano il tonfo di un corpo che cadeva a terra. Intimata nuovamente la resa, essi potevano notare due uomini e una donna avanzare carponi nel corridoio provenendo da una stanza laterale. A questo punto era possibile far luce con un faro in dotazione. Seguiva immediatamente da parte dei tre una brusca reazione e i carabinieri, notato che uno dei due uomini impugnava una pistola e la donna una bomba a mano, riaprivano il fuoco con tutte le armi. Cessato il fuoco si constatava che i tre erano stati colpiti a morte»8.
Casazza, però, può annotare subito dopo:
La versione fornita alla magistratura dai carabinieri è evidentemente edulcorata da alcuni particolari non irrilevanti. Il più importante si riferisce ai tempi in cui si sviluppa la sparatoria all’interno dell’appartamento. Secondo il comunicato della procura sembra svolgersi in due fasi ben distinte mentre, nella realtà, subito dopo il ferimento del maresciallo Benà, i militari non sospendono il fuoco: «In tutto, dall’esplosione del primo colpo, passarono tre minuti. Un inferno di fuoco, un inferno», ricorderà il capitano Riccio nel febbraio del 2004 nel corso di un intervista […]
Il capitano del nucleo antiterrorismo nega categoricamente di essere stato in possesso delle chiavi dell’appartamento, fatto che, invece, viene da più parti ipotizzato. Moretti, ad esempio, lo affermerà con certezza: «I carabinieri avevano le chiavi della base, le avevano trovate in tasca a Rocco Micaletto. Rocco non aveva detto parola, ma Peci aveva detto loro dov’era la base e hanno potuto entrare senza neanche sfondare la porta». Riccio dice invece di aver suonato il campanello, di essersi qualificato e di aver ordinato di aprire per consentire una perquisizione.
«Dall’interno sentimmo dei passi, pensammo che qualcuno ci avrebbe aperto. Invece chi si avvicinò diede altri due giri alla serratura. Allora impartii a Benà e all’altro maresciallo l’ordine di sfondare la porta. Non usammo alcun attrezzo, lo fecero a calci, portavano stivaloni. Una volta saltata la serratura ci trovammo di fronte a una spessa tenda nera, da cinema, che ci coprì subito la visuale dell’ingresso. La scostammo subito, all’interno iniziò a filtrare la luce delle scale. “Arrendetevi!”, gridai. Benà sollevò la visiera del casco, era appannata dal sudore. Fu un attimo. Sentii gli spari poi vidi il maresciallo Benà cadere all’indietro lentamente, come al rallentatore.
[…] Nel frattempo sparai col fucile a pompa, cinque colpi in rapida successione. Iniziò l’inferno». Il capitano racconta che a quel punto i suoi tre uomini rimasti nel pianerottolo entrano a loro volta nell’appartamento iniziando a sparare all’impazzata. «Sparavano tutti. Ad un certo punto gridai: “Venite avanti, arrendetevi!”. Sentii una voce: “Hanno una bomba!”, era un mio uomo. Riprendemmo a sparare. Ricaricai un’altra volta il fucile a pompa. Fu un inferno, un inferno»9.
 Del resto che in via Fracchia sia andata in scena una vera e propria carneficina è l’impressione generale suscitata nei cronisti fatti entrare nell’appartamento (uno per volta e sotto la guida di un sottufficiale dell’Arma) ben undici giorni dopo i fatti.
Del resto che in via Fracchia sia andata in scena una vera e propria carneficina è l’impressione generale suscitata nei cronisti fatti entrare nell’appartamento (uno per volta e sotto la guida di un sottufficiale dell’Arma) ben undici giorni dopo i fatti.
I fori delle pallottole sui muri sono moltissimi e gli schizzi di sangue, in corridoio, arrivano sin quasi al soffitto: difficile pensare che i brigatisti siano stati colpiti mentre avanzavano carponi e sono in molti a notarlo. «Quando Gad Lerner ebbe la possibilità di entrare in quella casa – ricorderà Giuliano Zincone, giornalista del “Corriere della Sera” – ci raccontò di aver visto fori di proiettili ovunque. Una carneficina, insomma. Quattro morti, tutti brigatisti, ci sembrarono subito troppi. Non era possibile pensare a un conflitto a fuoco come invece sostenevano i carabinieri. Ritenevamo che potevano esservi altri modi, meno cruenti, per portare a termine il blitz».
Mario Moretti, molti anni dopo, sarà ancora più esplicito: «La notte del 28 marzo i carabinieri sorpresero i compagni nel sonno e li uccisero deliberatamente, tutti. È vero che a Genova non eravamo stati teneri, avevamo attaccato delle pattuglie di carabinieri e c’erano stati dei morti, ma quello fu un macello deliberato che potevano evitare; invece decisero di sbatterlo in faccia a tutti. Ci misero tanto zelo che un proiettile ferì accidentalmente anche uno di loro. Dalla Chiesa voleva dimostrare la decisione dello Stato, la potenza dei corpi speciali e darci una lezione che non lasciasse dubbi: nessuno doveva uscire vivo da quella base». Una lettura di parte? Senza dubbio. Ma che la versione ufficiale fornita da carabinieri e procura non sia del tutto attendibile lo rivelano anche altri particolari.
Sul muro del pianerottolo, a circa trenta centimetri da terra ci sono quattro fori provocati da una raffica di mitra; com’è possibile, se la sparatoria si è svolta solo all’interno dell’appartamento e se i carabinieri hanno sparato solo verso il fondo del corridoio? Ma, fatto ancor più strano, la porta d’ingresso dell’interno 1 non presenta segni di scasso alle serrature (una sola delle tre risulta chiusa), ma mostra solo la parte fissa di un catenaccio divelta. Per gli inquirenti questo basta a dire che «le serrature appaiono forzate» ma il fatto non si spiega se è vero che i carabinieri non avevano le chiavi della base. Il maggior numero di bossoli, poi, si trova infondo al corridoio, davanti alla camera da letto in cui dormivano tre dei quattro brigatisti, eppure, sia nella versione di Riccio, sia in quella della procura, si sostiene che i militari fecero fuoco dall’ingresso. Inoltre l’unico colpo che i brigatisti avrebbero esploso viene attribuito all’arma impugnata da Betassa, una calibro 9, e il bossolo espulso viene ritrovato in camera da letto, segno che il brigatista ha sparato dal fondo del corridoio. Come è possibile, visto che davanti a lui c’erano gli altri tre compagni? Come se non bastasse, a rendere ancora più sospetta l’intera ricostruzione dei fatti, c’è il ritardo con il quale i carabinieri presentano il loro rapporto e la cortina di ferro che gli uomini di dalla Chiesa stendono attorno all’appartamento impedendo a chiunque, compreso ai magistrati, di entravi per più di una settimana. Che cosa si doveva nascondere o cercare in quella irrituale solitudine investigativa?10
Sulla disposizione dei quattro corpi lungo il corridoio o a ridosso delle camere e sul fatto che presentassero tutti un foro di entrata dei proiettili che andava in linea quasi orizzontale dalla nuca verso la fronte non c’è poi molto da aggiungere rispetto a quanto riporta ancora Casazza attraverso le testimonianze giornalistiche o dei periti, ma almeno, prima di chiudere, occorre qui ricordare la figura di Annamaria Ludmann, oltraggiosamente segnalata in precedenza come donna dai facili costumi, a causa del “via vai di uomini” nel suo appartamento.
Nella piantina dell’appartamento allegata al rapporto dei carabinieri sul blitz di via Fracchia, il corpo di Annamaria Ludmann è indicato con il numero 3: giace in corridoio, preceduto dai cadaveri di Riccardo Dura e Piero Panciarelli e seguito da quello di Lorenzo Betassa. «Il cadavere numero 3 è quello di una donna che giace bocconi trasversalmente al corridoio con le gambe estese tra la porta del ripostiglio. Braccia indotte, avambracci flessi, lato sinistro del viso rivolto sul pavimento. Veste pullover avana, sottoveste beige, mutandine rosa e calza scarpe di corda. In corrispondenza della testa vasta chiazza di sangue di forma irregolare. Nell’angolo interno formato dal braccio ed avambraccio destro si nota la presenza di un paio di occhiali da vista e di una bomba a mano MK
tipo ananas»11.
 Una sottoveste, le mutandine, uno sguardo quasi voyeuristico sul corpo di una donna di poco più di trent’anni di cui sembra rimanere poco nella storia, drammatica di quegli anni, se non il fatto che fosse sposata con un uomo che sarà intervistato poco dopo la sua morte violenta. Di più ci dice forse, e con meno spreco di parole, la lettera di addio a lei indirizzata da una collega, Liliana Boccarossa, impiegata presso il centro culturale francese Galliera, e inviata al «Manifesto» pochi giorni dopo l’assalto all’alloggio di via Fracchia.
Una sottoveste, le mutandine, uno sguardo quasi voyeuristico sul corpo di una donna di poco più di trent’anni di cui sembra rimanere poco nella storia, drammatica di quegli anni, se non il fatto che fosse sposata con un uomo che sarà intervistato poco dopo la sua morte violenta. Di più ci dice forse, e con meno spreco di parole, la lettera di addio a lei indirizzata da una collega, Liliana Boccarossa, impiegata presso il centro culturale francese Galliera, e inviata al «Manifesto» pochi giorni dopo l’assalto all’alloggio di via Fracchia.
«Parlavi poco di te, mai nessuno ti aveva insegnato questo lusso. […] Ricordavi la sofferenza della scuola per ricchi dove ti avevano mandato i tuoi. Accennavi a un matrimonio fatto per andare via di casa e presto degenerato in violenza. E poi c’erano le tue paure: paura di non valere niente, paura di non essere all’altezza (di che cosa, poi?), paura della gente: e un’enorme solitudine»12.
Però, in un mondo in cui, alla fine, ogni lavoro sporco non costituisce mai altro che l’altra faccia del perbenismo borghese e della sua illusoria legalità, il 3 settembre 1982 a Palermo, lo stesso generale dalla Chiesa sarebbe stato ripagato per il suo servizio con la medesima moneta, per mezzo di un altro braccio armato: quello della Mafia, maestra insuperata di ogni “lavoro bagnato”.
P. Casamassima, Gli irriducibili. Storie di brigatisti mai pentiti, Editori Laterza , Bari — Roma 2012, p.16 ↩
P. Casamassima,op. Cit., p.79 ↩
P. Persichetti, La polizia della storia. La fabbrica delle fake news nell’affaire Moro, 2022; C. Galmozzi, Figli dell’officina. Da Lotta Continua a Prima linea: le origini e la nascita (1973-1976), 2019; A. Tanturli, Prima Linea. L’altra lotta armata (1974-1981), 2018; M. Clemeti, P. Persichetti, E. Santalena, Brigate Rosse. Dalle fabbriche alla «campagna di primavera». Vol. I, 2017; G. Donato, «La lotta è armata». Sinistra rivoluzionaria e violenza politica in Italia (1969-1972), 2014. ↩
Si veda in proposito: P. Piano, La «banda 22 ottobre». Agli albori della lotta armata in Italia, DeriveApprodi, Roma 2008. ↩
L’autore delle presenti righe si scusa con Galileo Galilei per aver preso in prestito la sua idea di difalcamento degli impedimenti, intesa a livello di ricerca per togliere di mezzo gli ostacoli alla proposizione di una una nuova ipotesi scientifica. ↩
Niccolò Bozzo, all’epoca braccio destro del generale dalla Chiesa. ↩
A. Casazza, Gli imprendibili, DeriveApprodi, Bologna 2025, p. 368. ↩
A. Casazza, op. cit., pp. 368-369. ↩
Ibidem, pp. 369–370. ↩
Ivi, pp. 371-372. ↩
Ivi, p. 364. ↩
Cit. in Casazza, p. 362. ↩



