di Franco Pezzini
 (Dell’autore di questa rassegna è uscito da poco in libreria Fuoco e carne di Prometeo. Incubi, galvanisti e Paradisi perduti nel Frankenstein di Mary Shelley, per i tipi Odoya, Bologna 2017.)
(Dell’autore di questa rassegna è uscito da poco in libreria Fuoco e carne di Prometeo. Incubi, galvanisti e Paradisi perduti nel Frankenstein di Mary Shelley, per i tipi Odoya, Bologna 2017.)
Il lettore che nel periodo successivo all’11 marzo 1818 nota sul bancone del libraio un’opera fresca di stampa di cui ha letto alcune recensioni, non può immaginare che quel romanzo, tirato da Lackington, Hughes, Harding, Mavor, & Jones nel modesto numero di cinquecento copie, sia destinato a cambiare parecchie cose nell’immaginario collettivo. Sul termine “fresca di stampa” dobbiamo intenderci, perché materialmente il volume è uscito dalla tipografia a Capodanno: ma è vero che nei primi due mesi, e nonostante un certo movimento (rilascio di esemplari, consegna di quelli per il copyright, invio ai giornali o a scrittori amici, e naturalmente alle librerie), non sembra filarselo quasi nessuno, e solo a marzo la novità editoriale inizia ad avere il botto di recensioni. Se ne parla su “La Belle Assemblée, or Bell’s Court and Fashionable Magazine” e “The Edinburgh Magazine and Literary Miscellany; A New Series of ‘The Scots Magazine’” in date non specificate del mese, sul “Blackwood’s Edinburgh Magazine” (con la recensione di Walter Scott) il 20 marzo a Edimburgo e il 1° aprile a Londra, su “The British Critic”, “The Gentleman’s Magazine” e “The Monthly Review” in date non specificate di aprile… Al punto che ottime edizioni (Oxford World’s Classic, University Chicago Press…) lo danno per edito decisamente nel marzo o aprile, e magari proprio il citato 11 marzo. In realtà sarebbe bizzarro perché in quella data la famiglia dell’autore – anzi autrice, che ovviamente ha voluto vedere l’avvio editoriale – chiude le borse per partire verso il Continente, imbarcandosi il giorno dopo a Dover per Calais: ma la data che associa alla partenza resta simbolicamente significativa e di svolta. Nel libro, Frankenstein di Mary Shelley (ancora coperta da un pudico anonimato), la Creatura, dopo una fase di vita defilata, inizia a colpire in assenza e anzi a notevole distanza geografica dal suo creatore; ma anche il romanzo, dopo il primo periodo defilato, dopo l’11 marzo inizia a “colpire” in assenza e a notevole distanza dalla sua autrice. A colpire i recensori, i lettori da loro indirizzati a quelle pagine, gli uomini di teatro che si approprieranno dell’opera iniziando a trasformarla…
Se insomma oggi – a dirla in linguaggio mutuato dalla liturgia – natale ed epifania di un romanzo devono essere estremamente ravvicinati (se no, si dice, non “funziona”), ciò non è sempre stato vero: e possiamo ben festeggiare entrambi i prossimi bicentenari del Frankenstein, il 1° gennaio e poi in marzo – magari il simbolico 11 –, per il loro rispettivo peso. Iniziando magari a (ri)prenderlo in mano con occhi (il più possibile) vergini: come tutti i romanzi assurti a mito, il capolavoro di Mary Shelley è infatti più conosciuto per i suoi derivati (soprattutto, ma non solo cinematografici) che per i contenuti, e il rischio è di leggerlo col pregiudizio delle pur geniali trasposizioni, che però restano molto libere.
A badare a cosa l’autrice realmente scrive, scopriamo che la Creatura non assomiglia se non in minima parte al “Mostro” dell’immaginario collettivo; che il modo di costruirla e persino l’attrezzatura hanno ben poco a che vedere con le straordinarie apparecchiature steampunk cui siamo abituati; ma soprattutto che il senso dell’apologo non è affatto quello un po’ reazionario e ostile alla scienza che il nome Frankenstein evoca all’uomo della strada. In scena è una grande metafora sulla responsabilità, a ogni livello: a partire da quella verso le creature che nella nostra cerchia di rapporti “costruiamo” e nutrono legittime attese verso di noi. Ma il senso voluto da quella riflessiva, un po’ ribelle, affascinante ragazzina (ricordiamo che i personaggi principali del romanzo, Creatura compresa, sono poco più che adolescenti) nutrita di istanze libertarie si allarga ad abbracciare dimensioni sociali, politiche… Quello dunque della scienza è soltanto uno dei campi interessati: importante, certo, ma senza le implicazioni pavide che infinite banalizzazioni hanno rovesciato su una grande storia d’amore – Victor è anzitutto il partner amatissimo e nevrotico, ammirato e criticato, Percy Bysshe Shelley – e di dolore. Come in genere i capolavori della letteratura, Frankenstein non è insomma un romanzo a tesi, ma una macchina per pensare dove precipitano conati d’angoscia, frustrazioni, fantasmi personalissimi dell’autrice e generalissimi di un mondo.
Il bicentenario ovviamente ha già iniziato a impattare sull’editoria anche in Italia. Se meriterebbe proporre una versione del Frankenstein 1818 – cioè la prima, più ruvida e ribelle, e con alcune significative divergenze rispetto a quella definitiva e levigata 1831 generalmente presente nei cataloghi – già sono apparsi vari testi nuovi o si annunciano riedizioni di altri proposti, sia in tema Frankenstein che più in generale sull’autrice.
 Fin da settembre è per esempio approdato in libreria a firma di Adriano Angelini Sut il buon saggio divulgativo – non è una dequalificazione, c’è bisogno di buona divulgazione – Mary Shelley e la maledizione del lago (Giulio Perrone, Roma). Vi si presenta con qualche concessione alla docufiction (in dialoghi ipotetici) il momento genetico di Villa Diodati e, come un’ombra, ciò che seguirà nel tessuto delle vite coinvolte, fino alla morte dell’autrice (1851) e oltre. Un teatro di figure carismatiche che non a casa ha dato la spinta a vari film e porzioni di sceneggiati TV per l’intensità delle passioni coinvolte.
Fin da settembre è per esempio approdato in libreria a firma di Adriano Angelini Sut il buon saggio divulgativo – non è una dequalificazione, c’è bisogno di buona divulgazione – Mary Shelley e la maledizione del lago (Giulio Perrone, Roma). Vi si presenta con qualche concessione alla docufiction (in dialoghi ipotetici) il momento genetico di Villa Diodati e, come un’ombra, ciò che seguirà nel tessuto delle vite coinvolte, fino alla morte dell’autrice (1851) e oltre. Un teatro di figure carismatiche che non a casa ha dato la spinta a vari film e porzioni di sceneggiati TV per l’intensità delle passioni coinvolte.
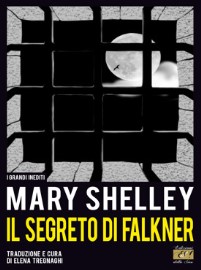 È poi appena comparso in novembre il romanzo ultimo di Mary Shelley, Il segreto di Falkner (Falkner, molto ben curato da Elena Tregnaghi, Postfazione di Elisabetta Marino, nella collana I grandi inediti diretta da Giorgio Leonardi, Edizioni della Sera, Roma 2017). Datata a quel 1837 anno di avvio dell’età vittoriana, l’opera rappresenta dunque in qualche modo una cerniera ideale tra due mondi che in quel momento ancora inavvertitamente si compenetrano. Protagonista della storia drammatica (non propriamente gotica, ma certo a tinte forti) è una ragazza coraggiosa, Elizabeth, cui Mary – che non si ritrova più nel radicalismo dei suoi giorni verdi, ma combatte per valori cui non ha abdicato – dona evidentemente parecchio di sé. Il romanzo merita senz’altro una riscoperta.
È poi appena comparso in novembre il romanzo ultimo di Mary Shelley, Il segreto di Falkner (Falkner, molto ben curato da Elena Tregnaghi, Postfazione di Elisabetta Marino, nella collana I grandi inediti diretta da Giorgio Leonardi, Edizioni della Sera, Roma 2017). Datata a quel 1837 anno di avvio dell’età vittoriana, l’opera rappresenta dunque in qualche modo una cerniera ideale tra due mondi che in quel momento ancora inavvertitamente si compenetrano. Protagonista della storia drammatica (non propriamente gotica, ma certo a tinte forti) è una ragazza coraggiosa, Elizabeth, cui Mary – che non si ritrova più nel radicalismo dei suoi giorni verdi, ma combatte per valori cui non ha abdicato – dona evidentemente parecchio di sé. Il romanzo merita senz’altro una riscoperta.
Che, al di là degli anniversari specifici, il gotico appaia un linguaggio molto più congruo ai nostri tempi di quanto spesso si creda – con le impennate e gli eccessi, ma anche le provocazioni più sottili, e quella cartapesta di un teatro che può inscenare istanze serissime – ricomincia a venire intuito anche a livello collettivo. È di lì in fondo, dal seminale Castello d’Otranto (1764), che nascono i generi moderni: e se AD 2017 non siamo ancora nella fase ascendente di quei picchi trentennali di successo gotico che hanno connotato il Novecento per il traino del cinema, e potrebbero riproporsi nel nuovo secolo (trentennali, cioè guarda caso della durata di una generazione, quasi a suggerire che si tratti di un linguaggio di “iniziazione” immaginale, una sorta di rito collettivo di passaggio) fin d’ora soprattutto i piccoli editori brillano per attenzione. Merita dunque anche da questo punto di vista visitare le manifestazioni a loro dedicate, come la romana Più libri più liberi aperta in questi giorni.
 Qualche testo lo si è citato, ma in realtà non c’è che l’imbarazzo della scelta. Per dire, Beat di Milano ha ripubblicato mesi fa a cura di Sergio Marconi Il vecchio barone inglese di una delle prime Madri gotiche antesignane di Mary Shelley, cioè Clara Reeve (1777 come The Champion of Virtue, 1778 col titolo più noto The Old English Baron), giunto qualche anno dopo la birichinata grottesca e onirica di Walpole e invece orribilmente serio. Che pure merita la rilettura, tanto più che è il vero battistrada per il successivo gotico “di consumo” ma anche per una serie di romanzi ben altrimenti brillanti, a partire da quelli di Ann Radcliffe.
Qualche testo lo si è citato, ma in realtà non c’è che l’imbarazzo della scelta. Per dire, Beat di Milano ha ripubblicato mesi fa a cura di Sergio Marconi Il vecchio barone inglese di una delle prime Madri gotiche antesignane di Mary Shelley, cioè Clara Reeve (1777 come The Champion of Virtue, 1778 col titolo più noto The Old English Baron), giunto qualche anno dopo la birichinata grottesca e onirica di Walpole e invece orribilmente serio. Che pure merita la rilettura, tanto più che è il vero battistrada per il successivo gotico “di consumo” ma anche per una serie di romanzi ben altrimenti brillanti, a partire da quelli di Ann Radcliffe.  L’attivissima Nova Delphi di Roma ha riproposto invece quel testo incompiuto di grande fascino che è Il visionario di Friedrich Schiller (Der Geisterseher, 1789), nella traduzione classica di Giovanni Berchet (1838), magnificamente curato da Fabio Camilletti (già curatore nel 2015 per Nova Delphi del Fantasmagoriana letto a Villa Diodati) e dall’illusionista e scrittore Mariano Tomatis, fautore di una magia militante e dalle vivaci iniziative (si rinvia senz’altro al suo sito): una macchina per pensare sul tema di quell’illusione che si fa anche motore politico, come in fondo vediamo in azione fino agli ultimi (ma purtroppo non ultimi) epigoni nell’Italietta berluschina renzina grillina.
L’attivissima Nova Delphi di Roma ha riproposto invece quel testo incompiuto di grande fascino che è Il visionario di Friedrich Schiller (Der Geisterseher, 1789), nella traduzione classica di Giovanni Berchet (1838), magnificamente curato da Fabio Camilletti (già curatore nel 2015 per Nova Delphi del Fantasmagoriana letto a Villa Diodati) e dall’illusionista e scrittore Mariano Tomatis, fautore di una magia militante e dalle vivaci iniziative (si rinvia senz’altro al suo sito): una macchina per pensare sul tema di quell’illusione che si fa anche motore politico, come in fondo vediamo in azione fino agli ultimi (ma purtroppo non ultimi) epigoni nell’Italietta berluschina renzina grillina.
Però anche sul terreno della saggistica, su gotico e affini brillano uscite di grande interesse.  Odoya ha appena edito – 30 novembre 2017 – una sontuosa Guida al grottesco, a cura di Carlo Bordoni e Alessandro Scarsella (contributori assieme a Susanna Becherini, Francesco Galluzzi, Riccardo Gramantieri, Patrizia Magli, Giuseppe Panella), che ovviamente impatta sulla materia in discorso per aprire a sviluppi poi autonomi. Tra Rabelais, Bosch e Arcimboldo, Hugo (firmatario del “Manifesto del grottesco” in appendice, 1827) e Browning, freaks e mascherate, l’opera è un intero, trasversalissimo canto – letteratura e arti visive, filosofia e spettacolo – al “sublime orrorifico”. Già indicativo l’indice, che dopo un paio di capitoli introduttivi dei curatori vede articolare il discorso nei suoi richiami storici (mondo antico e via via fino al barocco e poi alla modernità), nelle forme diversificate di singoli ambiti (allegoria, maschere e carnevale, fiaba, circo, Grand Guignol, cinema…), nelle connotazioni che associamo al termine (eccesso, disarmonia, rovesciamento della realtà, deformità fisica, oscenità…), ma anche in alcune specifiche figure (diavoli, vampiri, fantasmi, mostri assortiti…), con ovvio spazio al gotico e appunto al Frankenstein. “Il brutto e il grottesco ne hanno fatta di strada per farsi accettare, per uscire dal silenzio e dall’emarginazione” scrive Bordoni nell’introduzione: “finalmente sono entrati a pieno titolo nelle forme riconosciute dell’espressività umana e si sono conquistati, a buon diritto, il posto che compete loro nell’estetica, nella storia della letteratura e dell’arte, al punto da giustificare una Guida al grottesco”.
Odoya ha appena edito – 30 novembre 2017 – una sontuosa Guida al grottesco, a cura di Carlo Bordoni e Alessandro Scarsella (contributori assieme a Susanna Becherini, Francesco Galluzzi, Riccardo Gramantieri, Patrizia Magli, Giuseppe Panella), che ovviamente impatta sulla materia in discorso per aprire a sviluppi poi autonomi. Tra Rabelais, Bosch e Arcimboldo, Hugo (firmatario del “Manifesto del grottesco” in appendice, 1827) e Browning, freaks e mascherate, l’opera è un intero, trasversalissimo canto – letteratura e arti visive, filosofia e spettacolo – al “sublime orrorifico”. Già indicativo l’indice, che dopo un paio di capitoli introduttivi dei curatori vede articolare il discorso nei suoi richiami storici (mondo antico e via via fino al barocco e poi alla modernità), nelle forme diversificate di singoli ambiti (allegoria, maschere e carnevale, fiaba, circo, Grand Guignol, cinema…), nelle connotazioni che associamo al termine (eccesso, disarmonia, rovesciamento della realtà, deformità fisica, oscenità…), ma anche in alcune specifiche figure (diavoli, vampiri, fantasmi, mostri assortiti…), con ovvio spazio al gotico e appunto al Frankenstein. “Il brutto e il grottesco ne hanno fatta di strada per farsi accettare, per uscire dal silenzio e dall’emarginazione” scrive Bordoni nell’introduzione: “finalmente sono entrati a pieno titolo nelle forme riconosciute dell’espressività umana e si sono conquistati, a buon diritto, il posto che compete loro nell’estetica, nella storia della letteratura e dell’arte, al punto da giustificare una Guida al grottesco”.
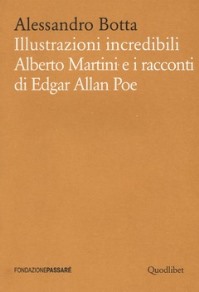 Qui il tema era visto col grandangolo, ma non mancano uscite più settoriali. Quodlibet di Macerata ha per esempio presentato nel 2017 un affascinante studio di Alessandro Botta, Illustrazioni incredibili. Alberto Martini e i racconti di Edgar Allan Poe, sull’opera dello scrittore moderno che può griffarsi del titolo di “più illustrato”. L’incontro postumo dell’Americano Maledetto – per cui l’etichetta di gotico non è certo inappropriata, pur con tutte le specificazioni che la critica suole recare – con il grande illustratore trevisano Alberto Martini (1876-1954) vede produrre la meravigliosa, imponente serie di tavole qui raccolte: tavole visionarie, alcune notissime (ma che nella completezza di un itinerario assumono un senso assai più ricco) e altre conosciute in genere soltanto dai cultori, con un commento sull’itinerario dell’artista.
Qui il tema era visto col grandangolo, ma non mancano uscite più settoriali. Quodlibet di Macerata ha per esempio presentato nel 2017 un affascinante studio di Alessandro Botta, Illustrazioni incredibili. Alberto Martini e i racconti di Edgar Allan Poe, sull’opera dello scrittore moderno che può griffarsi del titolo di “più illustrato”. L’incontro postumo dell’Americano Maledetto – per cui l’etichetta di gotico non è certo inappropriata, pur con tutte le specificazioni che la critica suole recare – con il grande illustratore trevisano Alberto Martini (1876-1954) vede produrre la meravigliosa, imponente serie di tavole qui raccolte: tavole visionarie, alcune notissime (ma che nella completezza di un itinerario assumono un senso assai più ricco) e altre conosciute in genere soltanto dai cultori, con un commento sull’itinerario dell’artista.
 Gli editori grandi riservano al gotico (e dintorni) attenzioni istituzionali senza grosse sorprese, anche se qualche eccezione è significativa. Come il monumentale volume (754 pp.) appena edito dal Saggiatore delle Lettere di Edgar Allan Poe, a cura di Barbara Lanati: un corpus che corre dal 1824 (Poe quindicenne sottoscrive una richiesta al governatore della Virginia dei Giovani Volontari di Richmond per poter trattenere in custodia le armi loro affidate durante il trionfale passaggio del vecchio La Fayette negli States) al fatale 1849 (tre lettere vergate una ventina di giorni prima della morte). Un volto cangiante di maschera in maschera, come ignoto a se stesso (a voler richiamare il titolo di una vecchia mostra torinese su ritratti fotografici di scrittori proposta da Sciascia, 1987, e del relativo catalogo edito da Bompiani, Ignoto a me stesso, che poneva proprio Poe in copertina), tra disvelamenti ed autofiction, drammi autentici e teatro, dove lo scarto sfuggente, continuo obbliga il lettore a porsi continue domande, e insieme panoramica (ancora una volta elusiva) sul dietro-le-quinte di una produzione che troppo spesso si presume nota.
Gli editori grandi riservano al gotico (e dintorni) attenzioni istituzionali senza grosse sorprese, anche se qualche eccezione è significativa. Come il monumentale volume (754 pp.) appena edito dal Saggiatore delle Lettere di Edgar Allan Poe, a cura di Barbara Lanati: un corpus che corre dal 1824 (Poe quindicenne sottoscrive una richiesta al governatore della Virginia dei Giovani Volontari di Richmond per poter trattenere in custodia le armi loro affidate durante il trionfale passaggio del vecchio La Fayette negli States) al fatale 1849 (tre lettere vergate una ventina di giorni prima della morte). Un volto cangiante di maschera in maschera, come ignoto a se stesso (a voler richiamare il titolo di una vecchia mostra torinese su ritratti fotografici di scrittori proposta da Sciascia, 1987, e del relativo catalogo edito da Bompiani, Ignoto a me stesso, che poneva proprio Poe in copertina), tra disvelamenti ed autofiction, drammi autentici e teatro, dove lo scarto sfuggente, continuo obbliga il lettore a porsi continue domande, e insieme panoramica (ancora una volta elusiva) sul dietro-le-quinte di una produzione che troppo spesso si presume nota.
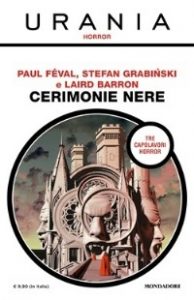 Si citava Ann Radcliffe: che per inciso figura come protagonista di un geniale, scatenato, ironico controcanto al gotico di uno dei padri del feuilleton, Paul Féval, cioè La città vampira o la sventura di scrivere romanzi gotici (La Ville Vampire, 1875). La scrittrice vi è immaginata in missione nei Balcani per aiutare amici nei pasticci: e in un contesto grottesco, pirotecnico e onirico da delirio acido dovrà fronteggiare vampiri che si sdoppiano, si trasfondono o si moltiplicano come entrando e uscendo da specchi, fino alla loro città babelica, folle come in una visione di Moreau e “superba sotto la maledizione di Dio, [che] viene chiamata Selene, […] nome greco della luna”. Ora, questa edizione con prefazione di Claudia Salvatori e tradotta magnificamente da Massimo Caviglione (anche nei tascabili, per favore, dateci più spesso professionisti del genere) è apparsa sì per un grande editore, Mondadori, ma solo in edicola all’interno di un volume curato da Giuseppe Lippi, Cerimonie nere (che comprende anche altri due gioielli horror, Il villaggio nero di Stefan Grabinski e La cerimonia di Laird Barron). Solo in edicola – quindi sparito subito – e come ultimo volume della serie Urania Horror, che avrebbe meritato ben maggiore visibilità di quella in effetti concessa (il che non va inteso in alcun modo come polemica con Lippi, che merita riconoscenza sempiterna per la sua opera a favore del fantastico e del gotico in Italia). Urge recuperarlo in qualche collana da libreria.
Si citava Ann Radcliffe: che per inciso figura come protagonista di un geniale, scatenato, ironico controcanto al gotico di uno dei padri del feuilleton, Paul Féval, cioè La città vampira o la sventura di scrivere romanzi gotici (La Ville Vampire, 1875). La scrittrice vi è immaginata in missione nei Balcani per aiutare amici nei pasticci: e in un contesto grottesco, pirotecnico e onirico da delirio acido dovrà fronteggiare vampiri che si sdoppiano, si trasfondono o si moltiplicano come entrando e uscendo da specchi, fino alla loro città babelica, folle come in una visione di Moreau e “superba sotto la maledizione di Dio, [che] viene chiamata Selene, […] nome greco della luna”. Ora, questa edizione con prefazione di Claudia Salvatori e tradotta magnificamente da Massimo Caviglione (anche nei tascabili, per favore, dateci più spesso professionisti del genere) è apparsa sì per un grande editore, Mondadori, ma solo in edicola all’interno di un volume curato da Giuseppe Lippi, Cerimonie nere (che comprende anche altri due gioielli horror, Il villaggio nero di Stefan Grabinski e La cerimonia di Laird Barron). Solo in edicola – quindi sparito subito – e come ultimo volume della serie Urania Horror, che avrebbe meritato ben maggiore visibilità di quella in effetti concessa (il che non va inteso in alcun modo come polemica con Lippi, che merita riconoscenza sempiterna per la sua opera a favore del fantastico e del gotico in Italia). Urge recuperarlo in qualche collana da libreria.



