di Dziga Cacace
 Gimme Five! (Storie di chitarristi senza dita)
Gimme Five! (Storie di chitarristi senza dita)
Chitarristi ce ne sono milioni. Ma originali, inventivi e unici, pochini. Del resto, esaurite tutte le scale possibili o l’onanismo più debilitante sul manico, cosa serve per emergere dalla folla e risultare felicemente diverso? Maltrattare lo strumento? Ma va’, son già trent’anni che qualcuno, la chitarra, l’ha sfasciata (Townshend), le ha dato fuoco (Hendrix), l’ha suonata coi piedi (Blackmore) o con un violino (Nigel Tufnel degli Spinal Tap, il record). Per cui, banalmente, certe volte l’impresa si compie suonandola con le dita, specie se ve ne manca qualcuna: il sacrificio estremo al dio della sei corde.
Ha cominciato il primo chitarrista jazz di fama mondiale, quel Django Reinhardt dalle mani veloci come saette. L’avrete sentito senza saperlo nei film di Woody Allen e in diverse pubblicità, ma la sua faccia tzigana da Nino Frassica non è popolare come meriterebbe. Eppure la chitarra swing gli deve tutto da quando incendiava i club di Pigalle negli anni Trenta. E con l’handicap. Già indiavolato entertainer a diciotto anni, lo zingaro fa vita grama e vive nel suo carrozzone, in un campo di nomadi a Parigi. Una notte casca una candela ed è il disastro: divampa un incendio e Django riesce a fuggire, ma la gamba destra è paralizzata (rifiuterà l’amputazione e userà il bastone tutta la vita) e anulare e mignolo della mano sinistra – quella con cui fare gli accordi – sono gravemente ustionati, rimanendo deformati e inutilizzabili. La testa però è dura e allora Django ripensa la sua tecnica solo in funzione di indice e medio.
 Sorretto dal quintetto Hot Club de France, va veloce come Yngwie Malmsteen plettrando accordi impossibili per i quali ai comuni mortali, di dita, ne servirebbero otto. E non farebbe male anche un’estensione della mano degna di Mr.Richards dei Fantastici Quattro. Django muore presto (a 43 anni), per una congestione. Tipico di chi è quasi bruciato vivo e, da zingaro che suonava la musica dei neri, è sopravvissuto al nazismo.
Sorretto dal quintetto Hot Club de France, va veloce come Yngwie Malmsteen plettrando accordi impossibili per i quali ai comuni mortali, di dita, ne servirebbero otto. E non farebbe male anche un’estensione della mano degna di Mr.Richards dei Fantastici Quattro. Django muore presto (a 43 anni), per una congestione. Tipico di chi è quasi bruciato vivo e, da zingaro che suonava la musica dei neri, è sopravvissuto al nazismo.
Grazie a Django non abbiamo solo pletore di jazzisti manouche, ma insospettabilmente anche un rocker che ha fatto la storia dell’hard. Tony Iommi ha inventato i riff massicci dei Black Sabbath e nessun chitarrista metal può prescindere da quel suono cupo e distorto. Per un pelo, però: il giovane Iommi è al suo ultimo giorno di lavoro prima di diventare musicista professionista. Lavora in fabbrica e si occupa del taglio di fogli di alluminio. Esattamente come succede a tappezzieri, falegnami e addetti ai telai meccanici, piagati dalla malattia professionale del dito mozzato, anche a lui basta un attimo di disattenzione e, voilà, sotto la pressa, rimangono le due ultime falangi di indice e medio della mano destra. Lui è mancino e con quelle dita lì, tiene le corde. Dramma. Depressione. Finché in ospedale, un amico lungimirante gli porta a sentire un disco di Reinhardt. Se ce l’ha fatta lui, ce la faccio anch’io, si dice Iommi. Ma come, con due dita mozzate? Tony non è inventivo solo sullo spartito e si costruisce delle protesi di plastica e gomma che attacca ai suoi moncherini. Alle estremità aggiunge delle pezzuole di cuoio, per ottenere il classico tocco della pelle. Certo, la sensibilità è nulla, ma a quella supplisce l’orecchio. E se le corde sono troppo dure, facile rimediare: la chitarra viene scordata, allentandole. E nasce così quel suono profondo e oscuro su cui l’imberbe Ozzy urlacchierà tutta la sua angoscia. Insomma, se non era per il destino infausto, niente doom e rock sepolcrale.
 È andata meglio a Jerry Garcia, l’orso buono hippie, l’interprete carismatico delle epiche (e talvolta un po’ scoglionanti) cavalcate lisergiche dei Grateful Dead, jam siderali dove le dita si arrampicavano sulle corde per delle buone mezz’ore. E di dita gliene mancava pure una. Jerry era un pacioccone profeta antiautoritario e pacifista e nessuno ha mai potuto vederlo mostrare il dito medio perché il suddetto volò via all’età di quattro anni. Colpo d’accetta ad opera del fratello, mentre si tagliava allegramente la legna in famiglia. E vabbeh, s’è detto Jerry, si può arpeggiare anche con quattro dita e l’impronta della sua grassoccia mano destra, senza le due falangi del medio, è diventata il suo emblema anche sulla copertina di un album.
È andata meglio a Jerry Garcia, l’orso buono hippie, l’interprete carismatico delle epiche (e talvolta un po’ scoglionanti) cavalcate lisergiche dei Grateful Dead, jam siderali dove le dita si arrampicavano sulle corde per delle buone mezz’ore. E di dita gliene mancava pure una. Jerry era un pacioccone profeta antiautoritario e pacifista e nessuno ha mai potuto vederlo mostrare il dito medio perché il suddetto volò via all’età di quattro anni. Colpo d’accetta ad opera del fratello, mentre si tagliava allegramente la legna in famiglia. E vabbeh, s’è detto Jerry, si può arpeggiare anche con quattro dita e l’impronta della sua grassoccia mano destra, senza le due falangi del medio, è diventata il suo emblema anche sulla copertina di un album.
Per tre illustri mutilati, abbiamo rischiato grosso anche con quello che è probabilmente il miglior chitarrista rock dalla morte di Hendrix: Jeff Beck le dita le ha ancora tutte ma per qualche ora ha avuto il pollice destro ridotto come una piadina. Innovatore a qualunque costo, mai adagiato su formule remunerative (pur avendole lanciate lui stesso), ha praticamente inventato l’hard rock con l’album Truth – del quale i Led Zeppelin han preso nota, forse più di una – e poi ha reso il jazz rock palatabile con Blow by Blow, l’unico album del genere che – per arrivare a fine ascolto – non richiede una laurea in astrofisica e due Aulin. Ultimamente sintetizza tutto lo scibile chitarristico su basi ritmiche alla Prodigy o ariose atmosfere sinfoniche, con avare uscite discografiche perché preferisce dedicarsi al suo hobby: Jeff Beck è (stato) un ricco misantropo che vive in campagna, godendo solo delle macchine custodite nel suo garage e passando il tempo a costruirle, ripararle, oliarle e lucidarle.
 Ed è proprio questa passione che gli ha fatto passare un pessimo quarto d’ora, quando una tavola di quercia, che Jeff usa per coprire la buca nella quale si sdraia per riparare le sue adorate macchinine, gli scivola sul pollice destro con vettura al seguito. Il sandwich tra quercia e chassis della macchina in riparazione gli appiattisce il pollicione come nei cartoni animati. Risultato: falangi spezzate e unghia sfasciata. Che la cosa sia dolorosa lo dimostra il fatto che è una tecnica di tortura consolidata (anche se non per lo stato italiano: vedremo quando ci penserà qualcuno, mah). Ma Jeff non ha nulla da confessare e siccome è un uomo all’antica si beve subito una litrata di whisky per tollerare il dolore. Invece si addormenta e solo alcune ore dopo riesce a raggiungere un pronto soccorso dove lo ingessano, ovviamente in maniera da non compromettere la sua capacità di suonare. Del resto c’è l’illustre precedente di Les Paul (che non è solo una chitarra, ma anche il genio che l’ha inventata): col braccio destro rotto, se lo fece ingessare con l’angolazione giusta per imbracciare lo strumento. Lieta fine: Jeff dopo qualche mese di comprensibile convalescenza torna a suonare meglio di prima.
Ed è proprio questa passione che gli ha fatto passare un pessimo quarto d’ora, quando una tavola di quercia, che Jeff usa per coprire la buca nella quale si sdraia per riparare le sue adorate macchinine, gli scivola sul pollice destro con vettura al seguito. Il sandwich tra quercia e chassis della macchina in riparazione gli appiattisce il pollicione come nei cartoni animati. Risultato: falangi spezzate e unghia sfasciata. Che la cosa sia dolorosa lo dimostra il fatto che è una tecnica di tortura consolidata (anche se non per lo stato italiano: vedremo quando ci penserà qualcuno, mah). Ma Jeff non ha nulla da confessare e siccome è un uomo all’antica si beve subito una litrata di whisky per tollerare il dolore. Invece si addormenta e solo alcune ore dopo riesce a raggiungere un pronto soccorso dove lo ingessano, ovviamente in maniera da non compromettere la sua capacità di suonare. Del resto c’è l’illustre precedente di Les Paul (che non è solo una chitarra, ma anche il genio che l’ha inventata): col braccio destro rotto, se lo fece ingessare con l’angolazione giusta per imbracciare lo strumento. Lieta fine: Jeff dopo qualche mese di comprensibile convalescenza torna a suonare meglio di prima.
 Ma parlando di dita sfasciate, la migliore riguarda un cantante, Ronnie James Dio, peraltro personaggio di tutto rispetto: di età indefinibile (sembra che sia del 1942), era già rugoso a metà anni Settanta e oggi è incomprensibile se sia già iniziato il processo di rattrapimento tipico degli anziani perché è alto quasi un metro e cinquanta (nelle foto coi Black Sabbath post Ozzy, usufruiva di uno spessore a terra per arrivare almeno alle spalle degli altri). Attivo fin dalla fine degli anni Cinquanta è diventato un vero Dio come voce epica dei Rainbow e, dopo la parentesi Black Sabbath, con il suo omonimo gruppo. Il vero cognome è Padovana e il nome d’arte viene da quello di un boss mafioso di Brooklyn che gli piaceva un mucchio, tal Johnny Dio responsabile di chissà quante teste rotte e gente cementata. Ad ogni modo, causa pratiche di giardinaggio estremo, Ronnie James ha rischiato di non poter più fare il gesto che l’ha reso popolare sui palchi di tutta la terra, le corna. Imparato dall’italica nonnina e popolarizzato tra gli yankee come “maloik”, è il suo autentico marchio di fabbrica. Sennonché zappettando in giardino nella sua magione, Ronnie James ha provato a spostare un pesantissimo e infido gnomo in marmo. Che s’è ribellato, è scivolato trascinandosi dietro lo gnomo in carne e ossa e s’è abbattuto sulla sua mano destra, staccandogli l’estremità del pollice. Dio confessa di aver subito pensato: e ora, come farò le corna? Uomo pratico, s’è presentato in ospedale con la mano sfasciata e il pollice mozzato nell’altra. Gliel’hanno subito riattaccato e tutto è bene quel che finisce bene: vedremo ancora Ronnie James fare il maloik. Tiè. (2009)
Ma parlando di dita sfasciate, la migliore riguarda un cantante, Ronnie James Dio, peraltro personaggio di tutto rispetto: di età indefinibile (sembra che sia del 1942), era già rugoso a metà anni Settanta e oggi è incomprensibile se sia già iniziato il processo di rattrapimento tipico degli anziani perché è alto quasi un metro e cinquanta (nelle foto coi Black Sabbath post Ozzy, usufruiva di uno spessore a terra per arrivare almeno alle spalle degli altri). Attivo fin dalla fine degli anni Cinquanta è diventato un vero Dio come voce epica dei Rainbow e, dopo la parentesi Black Sabbath, con il suo omonimo gruppo. Il vero cognome è Padovana e il nome d’arte viene da quello di un boss mafioso di Brooklyn che gli piaceva un mucchio, tal Johnny Dio responsabile di chissà quante teste rotte e gente cementata. Ad ogni modo, causa pratiche di giardinaggio estremo, Ronnie James ha rischiato di non poter più fare il gesto che l’ha reso popolare sui palchi di tutta la terra, le corna. Imparato dall’italica nonnina e popolarizzato tra gli yankee come “maloik”, è il suo autentico marchio di fabbrica. Sennonché zappettando in giardino nella sua magione, Ronnie James ha provato a spostare un pesantissimo e infido gnomo in marmo. Che s’è ribellato, è scivolato trascinandosi dietro lo gnomo in carne e ossa e s’è abbattuto sulla sua mano destra, staccandogli l’estremità del pollice. Dio confessa di aver subito pensato: e ora, come farò le corna? Uomo pratico, s’è presentato in ospedale con la mano sfasciata e il pollice mozzato nell’altra. Gliel’hanno subito riattaccato e tutto è bene quel che finisce bene: vedremo ancora Ronnie James fare il maloik. Tiè. (2009)
 Hey Dude: hai presente i Beatallica?
Hey Dude: hai presente i Beatallica?
A me le cover band che imitano anche l’abbigliamento, la gestualità e i vezzi di chi omaggiano mettono infinita tristezza. Quando ho visto (a tradimento) gli Stupido Hotel col cantante che introduceva i pezzi con le stesse identiche parole usate da Vasco sui vecchi dischi live, accento modenese compreso, ho avuto il magone per una settimana. Mi danno invece allegria estrema le cover band estrose, che affrontano i classici altrui con uno scatto creativo. Facendo un paragone pittorico: di contadini dipinti da Teomondo Scrofalo son piene le bancarelle, la Gioconda coi baffi di Duchamp è un pezzo unico. Mi divertono i Kiss nani (il nome dice tutto), i Nudist Priest (che suonano cover dei Judas Priest esibendosi nudi), i Gabba (che rifanno gli Abba alla Ramones) e i miei vent’anni sono stati allietati dai Dread Zeppelin, che suonavano cover reggae dei Led Zeppelin con un Elvis impersonator come cantante. Ma il top, oggi, è il riuscitissimo e per niente blasfemo incrocio tra Beatles e Metallica. Prendete le immortali melodie dei primi, come direbbe Mollica, e rivisitatele con le sonorità e il gergo dei secondi: risultato, i Beatallica. Ovviamente un quartetto, coi nomi dei componenti che mixano quelli dei baronetti con quelli dei quattro ex metal kid: Grg Hammetson alla solista, Jaymz Lennfield alla voce e alla ritmica, Ringo Larz alla batteria e Kliff McBurtney al basso. E pensare che tutto è nato per scherzo: per una festa di pesce d’aprile del 2001 viene prodotto un CD con delle cover dei Fab Four come se le avessero suonate i Four Horsemen (che già avevano realmente licenziato due edizioni di Garage Inc., raccolte di omaggi e rivisitazioni di brani altrui). Qualcuno abbocca allo scherzone ma soprattutto qualcuno mette i pezzi in Rete e cominciano downloading e popolarità. A quel punto si pensa a una band vera e dal 2004 si va on the road, con ottimi riscontri in America e Giappone. Ma per arrivare al successo (e al divertente Sgt. Hetfield’s Motorbreath Pub Band, oggi in vendita legalmente) si son dovuti affrontare anche alcuni discreti casini. Quando la Sony ha provato a fermare i Beatallica c’è stata una mezza sollevazione: qui da noi si sono sbattuti i Wu Ming, la nostra migliore band letteraria, mentre oltreoceano Mike Portnoy dei Dream Theater ha messo su il sito savebeatallica.com per dare assistenza legale ed economica alla band, tanto che pure Lars Ulrich ha dato il benestare all’operazione, facendosi perdonare la vicenda (tecnicamente: l’umiliante figura di merda) della causa con Napster. Lo avranno sicuramente convinto l’ascolto di Hey Dude e di I Want to Choke Your Band! (Febbraio 2009)
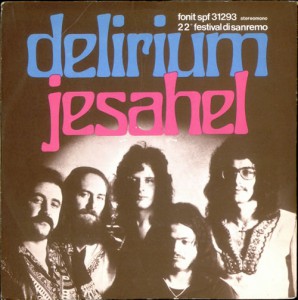 In preda al Delirium: Jesaheeeeeeeeel
In preda al Delirium: Jesaheeeeeeeeel
È il 24 febbraio1972 e 25 milioni di italiani sono davanti allo schermo, rapiti dal Festival di Sanremo. I bambini hanno avuto il permesso: stasera “dopo Carosello” si fa un’eccezione. Mike Bongiorno, con paurosi basettoni, introduce i Delirium sul palco dell’Ariston e una compagnia di venti hippie con caffettani, collane, gilet e flauto magico strega il pubblico col canto corale di Jesahel. Cominciano così i due anni di straordinario successo del gruppo genovese. C’era già stato Il canto di Osanna, ma i Delirium non compongono solo pezzi che avete sentito suonare alla noia dagli scout in gita; nei loro album c’è uno strano impasto di pop, rock, folk e jazz che poi i critici avrebbero chiamato prog. Quando a Ivano Fossati tocca la naja, il gruppo si reinventa con Martin Grice, da Birmingham. Due album e poi i Delirium appassiscono, finché arriva il nuovo millennio e tre superstiti di quella gloriosa formazione decidono di tornare. Il promotore è Peppino Di Santo, grande batterista che fu testimonial assieme a Carl Palmer (di Emerson Lake & Palmer) del primo gong per suonare rock della Paiste. Oggi la reliquia fa bella mostra (e ottimo suono) sul palco dei rinnovati Delirium. C’è sangue fresco ma alle tastiere impazza sempre Ettore Vigo: ha suonato coi Ricchi e poveri e coi fantastici Kim and the Cadillacs (un altro Sanremo, nel 1979, e finalmente un dubbio fugato: la benda da pirata del chitarrista era solo di scena!) e ancora oggi ricama fraseggi jazz o costruisce imponenti architetture sonore col suo organo. Mi racconta di come Bongiorno avesse rifiutato di citare, in quel Sanremo, il Mellotron che Ettore aveva avuto in prestito. L’avesse fatto, gli sarebbe stato regalato: altri tempi, altri sponsor, ma soprattutto un altro Bongiorno. Frontman della band è sempre Martin Grice. Oggi vive dietro Genova, a Sant’Olcese, paesino rinomato per dei salami da urlo. Questo zingaro del rock mi racconta in anglo-genovese del suo arrivo in Italia dopo aver suonato al Marquee coi grandi dell’epoca, da Hendrix ai Faces a Otis Redding. Preso al volo per la defezione di Fossati, prestò sax e flauto alla maturazione definitiva del sound del gruppo, un sound che ancora oggi fa faville. Hanno appena licenziato un ottimo live che ripercorre la storia della band, Vibrazioni notturne, ma in cantiere c’è pure un Delirium IV atteso da più di trent’anni. Vigo, Grice e Di Santo nella vita hanno anche fatto mestieri diversi, ma si capisce che sono musicisti veri quando gli si parla degli incontri che li hanno segnati. Come quello col maestro Severino Gazzelloni che concesse il suo flauto d’oro massiccio al coraggioso Fossati. Andò bene. E risentendoli oggi, è chiaro perché: sono maledettamente bravi. (Aprile 2007)
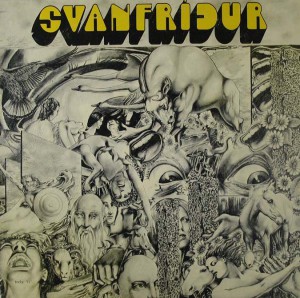 Forza Islanda!
Forza Islanda!
C’era una volta, quando ancora batteva il Cuore di Michele Serra, una rubrica utilissima e formidabile: con un riassunto e la pagina citabile, ti permetteva di millantare letture mai avvenute. Oggi, secondo le statistiche, leggere libri è praticamente una malattia rarissima e allora – piuttosto – fa tendenza vantare ascolti musicali remoti. E più sono remoti, più farete bella figura. Grazie a una poderosa menata firmata da Wim Wenders a un certo punto andava la musica cubana. E siamo ancora nel potabile e nel probabile. Poi il grande Kusturica ci ha rimbambito di fanfare balcaniche rubacchiate dal repertorio popolare da quel geniaccio di Bregovic. E infine – e ignoro il motivo – sono arrivati gli islandesi, ‘sti stramaledetti islandesi. Mi hanno intossicato prima coi Sugarcubes; poi, in pieni anni Novanta è toccato a Bjork: sguardo allucinato e manine inquietanti, menava di brutto i giornalisti e girava film folli con Von Trier. Adesso, per darsi un tono, niente fa colpo come proclamare la propria scoperta dei Sigur Rós; “Che pace, che melodie… sembrano i Pink Floyd con una spolverata di Nick Drake!”. Appunto: ho gli originali e dormo benissimo senza ottundenti vari. Che poi a me l’Islanda è pure simpatica (anche i Sigur Rós, via): fino a due mesi prima del crollo dei mercati era un’isoletta tranquilla. Poi è venuto giù tutto quando in qualche posto sperduto nel cuore degli USA un poveretto non ha trovato i soldi per pagare il mutuo. Effetto domino e i numeri, bit immateriali, si sono trasformati magicamente in solenni inculate, fisicissime queste. Ma torno in Islanda, perché nell’isola che era felice senza petrolio, dove son tutte dottir e un golf di lana costa come un straccio di panno, han pure fatto della musica che a me piace: per esempio gli ottimi Svanfridur. Nel 1972 hanno pubblicato un unico rarissimo album, un mischione originale di hard e prog cantato in inglese, con azzeccate intuizione di basso e archi. Proprio niente male. Anni fa, quando Bregovic era il non plus ultra, gelavo la conversazione citando i Bjelo Dugme del 1975, col giovane Goran che svisava blues. Oggi, alla bestia leghista che si lamenta degli immigrati sudamericani cui piace troppo la cerveza, rispondo con i dignitosi equadoregni Mozzarella (giuro). Assaggiati, sono altamente digeribili e, se vi piace il rock FM, valgono la pena. Ma la vera soddisfazione arriva quando saltan fuori i Sigur Rós. Sono troppo avanti: ascolto anche gli Svanfridur, io. (Dicembre 2009)
 Shel Shapiro è immortale, parola mia
Shel Shapiro è immortale, parola mia
Se dovessi elencare tutte le canzoni che hanno reso popolare Shel Shapiro, il pezzo sarebbe già bello e concluso. Ha alle spalle una carriera pazzesca, ricca di collaborazioni, scoperte, produzioni e riconoscimenti (e se dovessi fare tutti i nomi… vedi sopra), ma quando gli parli è sempre rivolto al futuro. La sua autobiografia è uscita l’estate scorsa e fa i conti con una vita, ma senza rimpianti o nostalgie, anzi, ed è tale la tensione verso i prossimi impegni che il titolo è programmaticamente Io sono immortale. Ci sono l’infanzia nella Londra del dopoguerra immersa nello smog, l’arrivo e la liberazione del corpo e della mente grazie al rock, la vitalità ingenua ma sinceramente energica dei Rokes, la tensione politica che è maturata nel tempo, le vicissitudini sentimentali e le gioie paterne, la frustrazione del successo di massa e il passaggio dietro le quinte per dedicarsi alla scrittura e alla produzione negli anni seguenti, rifiutando ad ogni costo la nostalgia televisiva (“piuttosto muoio di fame!”) alla corte di Baudo, Conti, D’Urso & company. La cosa gli avrebbe pur fatto fare qualche soldino ma lo avrebbe anche reso prigioniero di Bisogna saper perdere e delle domeniche pomeriggio via etere assieme ad altre cariatidi. Nel suo libro trovi la Roma dei Sessanta e la Milano dei Settanta solo come un inglese te le può raccontare e scopri anche liason inaspettate (l’amicizia con Mario Capanna) e altre più logiche ma mai sfruttate nel senso deteriore del termine (le sue interpreti Mina, Vanoni e Mia Martini, per dire), tutto permeato da uno humour che non sai se più british o yiddish. Shel è ribelle e capellone “oggi più di ieri e domani più di oggi”: non ha perso alcun entusiasmo e lo dimostra discorrendo davanti a una pasta col ragù e un bicchiere di rosso. Andiamo avanti per ore e confermo: è immortale e la sua saggezza non è data dall’età, ma dalla leggerezza e dall’ironia. Poi è tempo di farla finita, perché questo talentaccio è atteso da delle prove teatrali: già attore per Mario Monicelli in Brancaleone alle crociate, Shel adesso recita sul palco con Moni Ovadia. Dopo il successo di Sarà una bella società scritto col compianto Edmondo Berselli, è in tour fino a tutto marzo con Shylock: il mercante di Venezia in prova dove interpreta il personaggio eponimo. E non canterà Che colpa abbiamo noi, state sicuri. (Febbario 2011)
(Continua – 5)
Qui altre storie di Hard Rock Cafone
@DzigaCacace mette i dischi su Twitter



