di Sandro Moiso
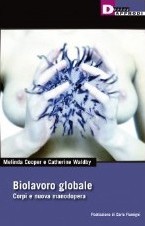 Melinda Cooper e Catherine Waldby, Biolavoro globale. Corpi e nuova manodopera, DeriveApprodi 2015, pp. 254, € 18,00
Melinda Cooper e Catherine Waldby, Biolavoro globale. Corpi e nuova manodopera, DeriveApprodi 2015, pp. 254, € 18,00
Difficilmente Marx, quando scrisse le sue pagine sulla sussunzione reale di tutti i processi di produzione e valorizzazione delle merci all’interno del capitale e, quindi, della sua completa appropriazione di ogni attività umana,1 avrebbe potuto immaginare che si potesse giungere alla situazione affrontata dalla ricerca di Melinda Cooper e Catherine Waldby.
Un testo importante che induce, necessariamente, a rivedere gran parte della storia del lavoro in regime capitalistico e delle strategie messe in atto per mantenere nelle mani del capitale il comando sulla forza-lavoro, anche laddove si siano rese necessarie delle riforme “democratiche” per la sua gestione.
Una ricerca che, guarda caso, ha avuto modo di svilupparsi a partire dal mondo anglo-sassone, in cui il pragmatismo degli obiettivi da raggiungere impone il superamento dell’attività meramente speculativa e permette, perciò, di conseguire risultati concreti nella ridefinizione dei nuovi contesti operativi con cui l’antagonismo sociale si trova oggi a fare i conti. Svolta a partire dall’ambiente universitario di Sidney che ha aiutato significativamente, anche dal punto di vista economico, le due autrici, come le stesse tendono a precisare fin dai ringraziamenti.
Melinda Cooper, docente presso il dipartimento di politiche sociali dell’Università di Sidney, e Catherine Waldby, professoressa presso l’Academy of Social Sciences of Australia e direttrice del Biopolitics of Science Research Network presso la stessa Università, fin dalle prime pagine focalizzano la loro attenzione sul lavoro clinico di coloro che prestano i propri tessuti, i propri corpi e il proprio liquido seminale a quella moderna branca dell’investimento capitalistico che passa sotto il nome di bioeconomia, di cui le ricerche e i prodotti del settore biomedico rappresentano uno dei settori di punta.
Settore nei confronti del quale “negli ultimi anni si è infatti formata un’ingente mole di opere sul lavoro cognitivo specializzato degli scienziati e sulla sua centralità nell’economia della conoscenza” mentre, allo stesso tempo, “la questione del lavoro di coloro che forniscono «in vivo» i materiali essenziali alla sperimentazione clinica e la questione dei tessuti – di chi li mette a disposizione – in nessun luogo sono state analizzate nei termini di un vero e proprio lavoro” (pag. 21)
Lavoro che, in ultima istanza e come ben dimostra il testo, sembra porsi come l’ultima frontiera dello sfruttamento fisico. Dallo sfruttamento della forza-lavoro allo sfruttamento del corpo tout court, in una dimensione ancora diversa da quella del corpo sfruttato a servizio delle schiavitù sessuali e della prostituzione. Sfruttamento che, in entrambi i casi, richiede un abbassamento dei costi di riproduzione della forza lavoro o dei corpi impegnati nelle varie mansioni.
Uno sfruttamento che vede poi, ancora una volta, al suo centro la donna e il suo corpo e in cui la diversità di genere o di “etnia” diventa determinante proprio ai fini del contenimento dei costi.
Uno sfruttamento in cui, capitale variabile e capitale costante, lavoro morto e lavoro vivo finiscono col coincidere nel corpo e/o sul corpo dello stesso essere umano, facendo sì che il capitale finisca non soltanto con l’essere il motivo dello sfruttamento, ma anche col fondersi con l’oggetto stesso dello sfruttamento e della produzione, portando a compimento definitivo quell’assunto di Marx contenuto nel “Capitolo VI inedito” per cui “lo sviluppo della ricchezza cosale avviene in opposizione e a spese dell’individuo umano”.2
Si potrebbe dire, a lettura ultimata, a spese, ancora una volta, dell’intera specie umana che si vede potenzialmente deprivata di quella che costituisce la caratteristica peculiare di tutte le specie viventi: quella di riprodursi liberamente. Mentre oggi, per le fasce meno garantite della popolazione, la riproduzione, oltre ad essere diventata un improbabile lusso, si è trasformata in una sorta di sfruttamento, ai fini della valorizzazione capitalistica, delle proprietà fisiologiche degli individui.
In tale contesto, anche se il mercato dei servizi di carattere biologico-riproduttivo è certamente molto più ristretto di quello tradizionale dei beni di consumo su scala planetaria, ciò che conviene maggiormente dal punto di vista dell’investimento e della speculazione finanziaria è legato proprio alla sproporzione tra il costo effettivo del lavoro-clinico e le plusvalenze realizzate a partire dal suo sfruttamento. Ma, per giungere a tali sviluppi del processo di valorizzazione, si è reso necessario giungere ad una totale precarizzazione ed esternalizzazione dei rapporti di lavoro.
“Da quando la produzione taylorista di massa ha raggiunto i propri limiti di redditività durante gli anni settanta, le aziende si sono mosse alla ricerca di alternative flessibili al suo diffuso assetto di organizzazione verticale, basato su una forza lavoro impiegata in modo permanente e a tempo pieno su scala nazionale. L’esternalizzazione implica una serie di strategie economiche: il subappalto, la cessione di segmenti non trascurabili di produzione a società terze; l’utilizzo di società di sevizi per adempiere alle funzioni necessarie a riprodurre il lavoro stesso (pulizia, ristorazione), […] la precarizzazione sistematica della forza lavoro. I posti a tempo pieno e indeterminato nelle aziende diventano sempre più residuali, così come settori sempre maggiori della forza lavoro vengono assegnati dalle agenzie di lavoro interinale. Assunti con contratti di lavoro part-time a tempo determinato o addirittura con contratti di lavoro a chiamata giornaliera e a ore.
Queste forme di lavoro non garantiscono certezza e continuità del reddito. Esse non godono neppure delle tutele legali che caratterizzano il contratto a tempo indeterminato, […] nessun diritto alla contrattazione sul luogo di lavoro. Le strategie di esternalizzazione hanno determinato l’imporsi di un’organizzazione flessibile e in rete del commercio «in cui le imprese trovano le risorse mancanti grazie all’abbondanza dei subappaltatori e di una forza-lavoro malleabile in termini di occupazione»” (pag. 45) Il che sintetizza abbastanza bene come il job act non costituisca tanto un «errore di percorso» nella normale dialettica tra capitale e lavoro mediata dallo Stato, quanto piuttosto un vero e proprio piano di ristrutturazione complessiva del lavoro e del suo costo nell’attuale fase di crisi del capitalismo occidentale.
Tanto più che “I rapporti flessibili che intercorrono tra datore di lavoro e lavoratore servono a ridurre i tempi di inattività nel processo di lavoro e trasferire l’incertezza delle fluttuazioni economiche dall’azienda alla forza-lavoro stessa. Se le regole di mercato per un determinato prodotto cambiano, l’azienda può assumere nuovi precari, licenziare i precedenti, senza termini di preavviso stabiliti per legge, con scarse restrizioni rispetto alla durata della loro giornata lavorativa. […] «Tutto ciò che non è direttamente produttivo è scartato in quanto tempo di non-lavoro, i costi di mantenimento della forza-lavoro vengono trasferiti ai lavoratori stessi»” così che “ il contratto di servizio senza interruzione, inteso come rapporto tra datore di lavoro e lavoratore definito per legge, può essere sostituito da un appalto di servizio, ovvero da un contratto commerciale a progetto per la fornitura di beni o servizi” (pag. 46)
Ed è proprio questa precarizzazione istituzionalizzata del lavoro che apre la strada al lavoro clinico di cui si parla nel testo: “quello di coloro che forniscono i materiali in vivo per il mercato della fertilità e partecipano alle sperimentazioni cliniche, […] organizzato, almeno negli Stati Uniti, come un appalto di sevizi, con particolari conseguenze per gli uomini e le donne che mettono a disposizione gameti e uteri per gli aspiranti genitori , così come per i soggetti che effettuano test clinici a contratto per conto delle organizzazioni di ricerca” (pag. 47)
Ma, come dimostra bene la ricerca di Cooper e Waldby, questa moderna riorganizzazione del lavoro affonda le sue radici in tempi non proprio recenti. In provvedimenti e strategie politiche ed economiche che sono servite a lasciare sempre una porta aperta alla possibilità di una ripresa del pieno comando capitalistico sul lavoro anche in periodi apparentemente più favorevoli ad un ampliamento dei diritti dei lavoratori.
Una di queste strategie è stata, per esempio, negli Stati Uniti quella della diversificazione dei livelli salariali e dei diritti dei lavoratori maschi bianchi rispetto a quelli delle lavoratrici donne e dei lavoratori afro-americani. In pieno New Deal infatti “la Social Security, legge approvata nel 1935, era «il solo e più importante atto in direzione della creazione di un welfare per gli Stati Uniti» eppure essa «selezionava e segmentava gli americani in base alla classe, classificando la popolazione in base a occupazione e status lavorativo. In aggiunta tale legge distingueva gli americani in base alla razza». Questi compromessi sociali hanno istituzionalizzato determinate gerarchie tra i diritti alle tutele sul lavoro e hanno valorizzato particolari forme di attività produttive. Esse hanno effettivamente protetto il corpo industriale maschio e bianco, dai rischi e dai pericoli connessi al luogo di lavoro caratteristico della produzione di massa, valorizzando una forma specifica di forza-lavoro […] Una netta distinzione di sfere evidente, se prendiamo in esame i tipi di lavoro che non rientrano nelle suddette tutele. Nel caso degli Stati Uniti, i provvedimenti della Fair Labor Standard non comprendevano la vendita al dettaglio, il lavoro agricolo, i servizi domestici, impieghi solitamente svolti da donne e afro-americani” (pag. 49)
Salta immediatamente all’occhio, per il lettore più attento, il paragone possibile tra quella situazione e quella creata anche dallo Statuto dei Lavoratori italiano, oggi allegramente mandato al macero, con le differenze che l’articolo 18 istituiva nei fatti tra lavoratori di serie A (grandi aziende), serie B (quelli delle aziende inferiori ai 15 dipendenti) e serie C (quelli dei contratti a termine, a chiamata o di scopo).
Ma non sono stati soltanto i contratti diversificati, anche in periodi di espansione economica e di lotte sociali, ad aver lasciato aperta la porta al ritorno trionfale del pieno comando capitalistico sul lavoro. C’è stata anche la teoria economica, in particolare quella della Scuola di Chicago.
“I più accaniti sostenitori del lavoro esternalizzato sono i teorici del capitale umano della scuola di Chicago, i quali dalla fine degli anni Cinquanta hanno cominciato ad elaborare le fondamenta concettuali per la privatizzazione dei rapporti di lavoro e la contrattualizzazione dei «servizi biologici» che si sarebbe realizzata concretamente solo in seguito.
Il concetto di capitale umano è diventato sinonimo di tutto il lavoro economico, ed è in gran parte utilizzato per indicare la necessità di investire nel sociale, allo scopo di rendere la forza-lavoro sempre più ubbidiente e «flessibile», adattabile ad ogni tipo di mansione” (pag. 53)
“Il capitalismo post-fordista mette al lavoro la vita in sé, «superando la distinzione tra produzione e riproduzione» fino a costituire una nuova forma di «biolavoro». In queste condizioni ogni «teoria del valore-lavoro» deve intendersi come «una teoria del valore della vita» […] L’industria farmaceutica esige un numero sempre più elevato di soggetti per la sperimentazione, per rispondere all’imperativo dell’innovazione. Il mercato della riproduzione assistita continua ad espandersi, dal momento che sempre più persone vogliono avere un figlio proprio ricorrendo alle tecniche di fecondazione assistita o di maternità surrogata […] Le industrie delle scienze della vita si basano su un’ingente forza-lavoro ancora non riconosciuta, cui vengono richiesti servizi legati ad esperienze molto viscerali, come il consumo di farmaci in via di sperimentazione, la trasformazione ormonale, l’eiaculazione, l’estrazione di tessuti e la gestazione, con procedure biomediche più o meno invasive” (pp. 30-31)
“Oggi l’industria farmaceutica trova i soggetti per le proprie ricerche[…] individuando nuove fonti di manodopera sperimentale nelle svariate forme di esposizione al rischio determinate dalle riforme neoliberiste di lavoro e Welfare. Oggi, le organizzazioni di ricerca a contratto reclutano abitualmente i soggetti di ricerca della fase I tra disoccupate/i, lavoratrici/ori a giornata, ex-detenute/i e migranti privi di documenti, proprio quel tipo di manodopera che quotidianamente sopporta le condizioni più pericolose e precarie di lavoro […] Nell’era post-fordista dell’informalizzazione generalizzata del lavoro, quella della sperimentazione clinica è la manodopera precaria per eccellenza, caratterizzata dalla «libertà» di assumersi rischi psico-fisici maggiori” (pag. 43)
Un’ultima citazione per chiudere il cerchio e prima di concludere: “Sorprende dunque che gli economisti della Scuola di Chicago e i teorici del diritto siano stati così veloci nell’anticipare la commercializzazione del biologico e nel sostenere la contrattualizzazione completa dei mercati dei tessuti umani. Richard posner e Richard Epstein, figure di spicco della Scuola di diritto ed economia, si sono impegnati per la piena applicaziobne dei contratti di maternità surrogata: Epstein si è spinto persino a raccomandare l’uso di strumenti contrattuali eccezionali […] allo scopo di far rispettare il trasferimento del figlio dalla madre surrogata ai suoi aspiranti genitori, mentre gary Becker ha sostenuto la necessità di ricorrere a incentivi monetari per aumentare la quantità di organi disponibili per trapianti, sia da donatori in vita che da cadaveri” (pp. 53-54)
Occorre fermarsi qui, anche se i dati di interesse e gli esempi contenuti nel testo sono ancora tantissimi e utilissimi. Il dato incontrovertibile è, però, che il capitale è entrato nei corpi e la lotta con la specie per la sua sopravvivenza passa oggi anche attraverso i corpi trasformati in macchine per la sperimentazione. Il capitale cerca di farsi natura e nel fare ciò la distrugge o, perlomeno, cerca di appropriarsene distruggendone le funzioni primarie di sopravvivenza e riproduzione.
Oggi si fa un gran parlare di procreazione assistita, come di una nuova frontiera del diritto e delle libertà individuali, ma intanto la natalità italiana è scesa al livello più basso dal 1861 e le statistiche ci dicono che a Brescia, per esempio, mediamente ogni donna ha un tasso di natalità di 0,8 figli. Negli anni della recinzione delle terre comuni e della espulsione dei piccoli contadini e dei braccianti dalle terre inglesi, nella seconda metà del Seicento, la natalità media delle famiglie diseredate era di 0,9 figli:3 il calo delle nascite non sarà forse allora collegato alla crisi economica, alla mancanza di risorse e alla devastazione ambientale? E l’appropriazione da parte di un segmento della società del diritto a riprodursi a discapito della stessa possibilità per il segmento più povero e meno garantito, non ci indica forse che la guerra definitiva tra capitale e lavoro e tra capitale e specie è appena cominciata? Per questo il libro di Cooper e Waldby può fornirci intanto un utile compendio per iniziare ad orientarci nel conflitto già in atto.
La questione è ampiamente riassunta e sviscerata in Jacques Camatte, Il capitale totale. Il «capitolo VI» inedito de «Il Capitale» e la critica dell’economia politica, Dedalo libri 1976 ↩
Giovanni Dettori – Nicomede Folar, Nota sulla traduzione a J.Camatte, op.cit, pag. 7 ↩
Si confronti Wally Seccombe, Le trasformazioni della famiglia nell’Europa Nord-Occidentale. Mille anni di storia tra feudalesimo e capitalismo, La Nuova Italia 1997 ↩



