 Joe Abercrombie, classe 1974, di Lancaster, Inghilterra, è considerato un delle voci più originali del fantasy contemporaneo. Gargoyle Books lo ha portato per la prima volta in Italia con The Heroes, il suo quinto romanzo, tradotto da Claudia Costantini e Serena Vischi e da poco uscito in libreria; noi lo abbiamo intervistato.
Joe Abercrombie, classe 1974, di Lancaster, Inghilterra, è considerato un delle voci più originali del fantasy contemporaneo. Gargoyle Books lo ha portato per la prima volta in Italia con The Heroes, il suo quinto romanzo, tradotto da Claudia Costantini e Serena Vischi e da poco uscito in libreria; noi lo abbiamo intervistato.
La prima cosa che colpisce di The Heroes è il fatto che scegli di raccontare solo tre giorni di una battaglia, puntando l’attenzione sui singoli personaggi dei due fronti. Scegli dunque un micromondo, o meglio una serie di micromondi, rispetto a quel macromondo che è di solito il “luogo” dei romanzi fantasy.
Spesso nel fantasy si punta a un’epicità basata sulla grandezza di scala, sia dal punto di vista geografico che temporale, con vicende che impiegano stagioni o anni per dipanarsi, su territori sterminati; io invece stavolta volevo portare nel fantasy l’epica tipica dei “filmoni di guerra” classici, penso a Gettysburg, penso a Quell’ultimo ponte, narrazioni in cui si ha un evento temporalmente molto condensato visto da una moltitudine di punti di vista, in modo da creare un mosaico complessivo fatto di spezzoni di battaglie, di scontri, di dialoghi e situazioni.
Volevo fare questa cosa innanzitutto per essere originale — perché essere originali è una buona ragione di per sé, specie in un genere spesso vittima di cliché — e poi perché a mio avviso il fantasy, anche più che un genere di magia, è un genere di guerra, ma troppo spesso la rappresentazione delle battaglie è “perfettina”, lucente, onorevole; io volevo mostrare quello che è veramente la guerra, un macello schifoso di fango, fatica e sangue, ma anche un incredibile incrociarsi di persone dai background e dai destini del tutto diversi.
È vero anche, però, che mi sono potuto permettere di fare tutto questo senza grossi problemi perché The Heroes è ambientato nello stesso mondo della trilogia The first law, che avevo già sviluppato a fondo.
In The Heroes fai largo uso di mappe, ce ne sono cinque, che raffigurano in realtà la stessa area in diversi momenti, un po’ come in un wargame, dove sono visualizzati su una mappa fissa gli spostamenti delle truppe.
Si, nella trilogia The first law avevo scelto di non pubblicare le mappe, ho creduto che fosse più interessante non metterle; trovo che in molti casi siano diventati uno dei tanti cliché del genere, il sintomo di una ossessione sull’ambientazione che non sempre è salutare: ovvio che è uno dei pilastri, ma per quanto mi riguarda mi interessano molto di più i personaggi. Con The Heroes però il discorso era diverso perché si parla di una battaglia, e per seguire una battaglia le mappe sono molto utili: in effetti nel mio caso non vengono tanto dai wargame — ero troppo pigro da ragazzino per mettermi a colorare tutte quelle miniature — quanto dalla pura e semplice storia militare, che ovviamente ne fa largo uso. Credo che nell’economia di questo romanzo le mappe dinamiche che ho introdotto abbiano due funzioni: dare una senso di realtà immediato, e permettere di seguire gli sviluppi della battaglia con maggiore facilità, senza perdersi troppo a cercare di capire cosa sta succedendo e dove, cosa che si dovrebbe tradurre in una maggiore leggibilità generale.
Si intuisce comunque leggendoti che, se non a quello dei wargame, sei molto legato al mondo dei giochi di ruolo.
Certamente. Ho giocato per anni a vari giochi di ruolo, e come quasi tutti ho cominciato con Dungeons & Dragons; direi anzi che nell’avvicinarmi al genere fantasy, il D&D ha avuto un ruolo ben più importante rispetto alla narrativa. Le prime cose che ho scritto erano infatti avventure e scenari, e in quel periodo leggevo più libri di storia che fiction di genere. Tutto questo si riflette in ciò che scrivo — per fortuna alcuni ingredienti di una buona campagna, come per l’appunto il world-building o la creazione di personaggi interessanti, sono anche gli ingredienti di un buon fantasy.
Questo romanzo si colloca, come accennavi prima, nel mondo di The first law, la trilogia uscita in lingua inglese tra il 2006 e il 2008. In Italia invece esce prima di quei tre libri. Che effetto può avere questa inversione dell’ordine di lettura?
La trovo una cosa interessante, non dannosa, no, perché l’idea era fare un libro a sé, leggibile anche da chi non conoscesse la trilogia di The first law. Poi è chiaro che io, avendola scritta, la conosco, e dunque questo libro è zeppo di riferimenti. Se uno legge prima The Heroes e poi gli altri avrà, credo, una percezione diversa dei personaggi: ne ritroverà svariati e quindi invece di vederli entrare in scena dal nulla conoscerà già alcuni dei loro tratti; alcuni li avrà già visti in azione, potrà immaginare come si comporteranno e quindi li seguirà in modo diverso. In ogni caso in The Heroes c’è tutto il mio modo di fare fantasy, quindi a qualcuno piacerà, allora avrà anche più soddisfazione: in Inghilterra chi ha apprezzato la trilogia si è beccato il “contentino” del libro aggiuntivo, mentre qui chi apprezzerà The Heroes potrà spararsi un’intera trilogia. Mica male, dai.
Il tuo modo di fare fantasy è caratterizzato anche da una quantità molto ridotta di elementi sovrannaturali, che di solito sono uno dei tratti fondanti del genere. Addirittura in rete ho letto gente che si lamentava per l’assenza di magia in The Heroes e ti dava meno “stelline” per questo.
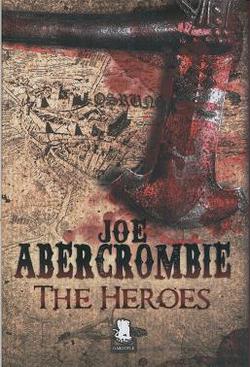 Be’, premesso che prendere meno di 5 stelline significa sempre distruzione e rovina totale (ride), non so, credo che la cosa che conta davvero siano i personaggi, la trama, lo scenario, non i sistemi magici o cosmologici coerenti. Credo anzi che il magico sia “più magico” quando ce n’è meno, e quando rimane inspiegato. Se qualcosa è raro e strano e sconosciuto, allora è anche eccitante. Non fraintendermi, c’è anche chi fa high fantasy ad alto potenziale magico e lo fa bene, ma per quanto mi riguarda cerco di ridurre questo elemento il più possibile.
Be’, premesso che prendere meno di 5 stelline significa sempre distruzione e rovina totale (ride), non so, credo che la cosa che conta davvero siano i personaggi, la trama, lo scenario, non i sistemi magici o cosmologici coerenti. Credo anzi che il magico sia “più magico” quando ce n’è meno, e quando rimane inspiegato. Se qualcosa è raro e strano e sconosciuto, allora è anche eccitante. Non fraintendermi, c’è anche chi fa high fantasy ad alto potenziale magico e lo fa bene, ma per quanto mi riguarda cerco di ridurre questo elemento il più possibile.
Un’altra diatriba tipica tra gli appassionati è quella delle armi e armature non realistiche o fuori epoca, che di fatto è un riflesso di una questione più grande, quella tra le necessità del realismo e quelle della messa in scena, della portata simbolica.
Personalmente mischio a piacere. Armi inglesi del tredicesimo secolo e armature francesi del quindicesimo? Va benissimo, dai, puoi combinare se lo desideri, l’importante è che l’insieme risulti credibile, il che non corrisponde esattamente a realistico: siamo in un mondo fantastico, del resto. Un realismo troppo aderente toglierebbe il fantastico dal fantasy, il che equivale a soffocarlo: tra gli obiettivi di questa narrativa, non dimentichiamolo, c’è anche l’intrattenimento, e se vado a fissarmi sulla forma delle punte degli stivali o della lama delle alabarde, finisco per diventare tecnico, e quindi freddo, e quindi poco accessibile, e quindi poco godibile, mentre a mio avviso il fantasy è un genere che per la sua stessa natura deve permettere al lettore di spaziare con l’immaginazione, senza ingabbiarlo in griglie formali.
A detta di vari autori e critici, in Italia il genere sarebbe troppo impantanato su Tolkien e sui suoi stilemi: a tuo avviso come è possibile superarlo (sempre che debba essere superato)?
Premesso che Tolkien ci mette comunque tutti in ombra, essendo non solo un grande scrittore fantasy ma un grande della letteratura in generale, credo sia importante ricordare che all’inizio non aveva questa posizione egemonica. Quando è uscito Il Signore degli Anelli, il genere aveva già decenni di storia: Tolkien ha cominciato a diventare dominante negli anni ’70 e da lì, e poi lungo tutti gli anni ’80, e ancora un po’ nei decenni successivi, schiere infinite di imitatori hanno trasformato gran parte di quello che lui ha fatto in un mucchio di cliché, ma lui non faceva cliché: la gente lo copiava, e lo copia adesso, perché le sue cose sono belle.
Da parte mia credo che sarebbe un peccato accodarsi e basta: è possibile, se non proprio superarlo, almeno aggiornarlo. Prendiamo Gli spietati, quello è un film che ha tutto del western classico, ma è anche una reinterpetazione del western, una modernizzazione la quale, oltre a rinnovare, si configura anche come un metawestern, perché contiene in sé un commento al genere stesso: ecco, credo che si debba fare lo stesso col fantasy. Non c’è una ricetta unica, ovvio, ma posso dire che la mia è cercare una strada moderna, personale, anche brutale, innanzi tutto cercando di non usare quella lingua artatamente vetusta che si vede a volte nel genere. E poi con lo humour, che però, più che una scelta ponderata, è proprio il modo in cui scrivo: quando leggo, voglio piangere ma anche ridere… Amo Tolkien ma di certo gli si può muovere una critica con tranquillità: non è un umorista. È solenne, fin troppo, tanto che a volte finisce per prendersi esageratamente sul serio e diventare pomposo. La verità invece è che la gente, tanto nel mondo reale che in quelli fantastici, spesso riesce a ridere, a sdrammatizzare, almeno per un attimo, anche durante i disastri, anche in mezzo all’oscurità.
Una piccola casa come Gargoyle ha compiuto un gesto importante traducendo e pubblicando un autore, come te, sconosciuto in Italia per chi non legge in originale. Altri autori che a tuo avviso varrebbe la pena tradurre?
Non sono aggiornatissimo su chi è stato esportato e chi no, quindi forse adesso faccio dei nomi e poi si scopre che sono già tradotti da anni… Ma ci provo: dunque, se fossi un editore italiano che vuole investire nel fantasy tradurrei: Lies of Locke Lamora di Scott Lynch, The Steel Remains di Richard Morgan, The Adamantine Palace di Stephen Deas, The Name of the Wind di Patrick Rothfuss, tutti ottimi romanzi, che sento vicini anche come “scuola”.



