di Dziga Cacace
Ogni pistola ha la sua voce… e questa la conosco.
Clint Eastwood in Il buono, il brutto, il cattivo
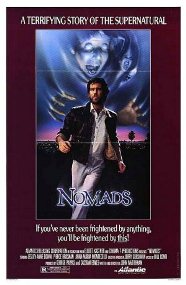 327 — L’orrido Nomads del sonnifero John McTiernan, USA 1986
327 — L’orrido Nomads del sonnifero John McTiernan, USA 1986
Che grande solenne stronzata! Ma vi sembra? Ingannato da una bella recensione di FilmTV e dal giudizio positivo del Mereghetti, registro immantinente da Tele+, convinto di vedere poi un piccolo cult dimenticato dal grande pubblico e dalla critica più banale. E invece no: chi mi ha illuso o non vede questo film da allora e ne ha un ricordo falso e ottenebrato oppure non capisce nulla. Perché Nomads è una irritante menata che non mena da nessuna parte. Comincia come un thriller rarefatto, praticamente fermo, immoto. Diventa poi una specie di horror che induce a pericolosissima pandiculazione e infine non conclude: non ho neanche un finale da spoilerarvi, maledizione! Ve lo riassumo in due righe, tanto la trama portante è praticamente inesistente: una dottoressa — la passatella Lesley-Anne Down (mio amore dai tempi di una Pantera rosa anni ’70) —, viene morsicata da un ricoverato che poi cricca secco. Da quel momento lei rivive l’esperienza del deceduto e vede che questo qui (Pierce Brosnan, espressivo come un busto del Pincio), un antropologo, ha seguito una banda di teppisti punk per le strade di Los Angeles. Ha scoperto — ullalalà — che sono dei vampiri nomadi e ne è stato soggiogato. La donna non rimane infettata (chissà perché, poi) e fugge dalla California con la moglie dell’antropologo. Fine, come se i vampiri avessero succhiato tutto il sangue alla vicenda. Maccheccazzo mi significa?
Vogliamo cercare astruse spiegazioni intellettualistiche tipo: vampiri come reietti della società? O ancora: tribù metropolitana come unica sopravvivenza al Capitale? Magari! Macché, niente! Solo immagini leccate e false… McTiernan è uno di quei cagnacci che hanno ottenuto un po’ di considerazione critica per aver diretto qualche film d’azione dove probabilmente la cinepresa la muoveva il direttore della fotografia. Perché qui un essere razionale capisce subito che non ne verrà fuori niente, che ‘sto film è una cagata abissale, noiosissimo, senza motivi di visione, esiziale nello svolgimento e completamente mancante di finale e senso. Musicato inoltre da quel matto di Ted Nugent! Complici della mia disavventura le attonite Barbara e Alessandra, abituate sí alla porcatina di gusto, ma non alla porcata porcata. (Vhs da Tele+; 5/10/02)
 328 — El Mariachi del discolo Robert Rodriguez, USA 1992
328 — El Mariachi del discolo Robert Rodriguez, USA 1992
Un mariachi si aggira per le desolate lande del Messico. Cerca avventure e ingaggi, ma sulla sua strada incrocia un gangster, Azul, che sta scappando dal terribile Moco con le armi nascoste nella custodia di una chitarra. A complicare il tutto ci si mette anche l’amore, perché il nostro eroe si innamora di Domino, la donna del boss. Equivoci, sangue, sesso, vendetta e maturazione. Niente male (specie il sesso, al di là del film). La leggenda dice che sia costato 7000 dollari e che Rodriguez si sia procurato i soldi vendendo il suo sangue e facendo la cavia. E vabbeh, io lavoro in tivù e ognuno si arrangia come può. Che El Mariachi sia girato in economia lo si vede subito dalla povertà delle location e dalla recitazione poco più che amatoriale (il film è stato girato in spagnolo in una cittadina messicana sulla borderline, con cast interamente indigeno), ma se la trama vive di uno scambio di persona abbastanza banale, lo sviluppo è fresco, con parecchie invenzioni. El Mariachi diventa all’improvviso cruento come uno splatter o ilare come un cartone animato di Tex Avery e Rodriguez — all’epoca ventitreenne – non si pone limiti: sparatorie, gag alla Keaton, inseguimenti, sequenze autoriali (con programmatiche lentezze espressive), in un mischione che fotografa in pieno il gusto postmoderno degli anni Novanta (ho letto che si dice così). Si vede che il regista è intelligente, ha gusto e non dimentica mai che c’è un pubblico da intrattenere. Non ha presunzioni da autore compiaciuto ma bada, nei limiti del possibile, a lasciare un suo marchio personale simpaticamente ribelle. E anticipa addirittura Tarantino nel recupero di certe atmosfere. Il film è stato forse sopravvalutato ma ha fatto conoscere uno dei pochi limpidi talenti della Hollywood odierna. A dieci anni dalla prima visione, c’è passato senza grandi sussulti, ma con muchissima simpatia. (Vhs da Italia1; 7/10/02)
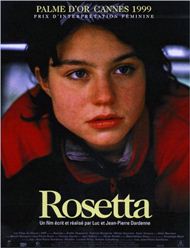 329 — Rosetta dei compagnoni Luc e Jean-Pierre Dardenne, Belgio 1999
329 — Rosetta dei compagnoni Luc e Jean-Pierre Dardenne, Belgio 1999
Questi due fratelli belgi devono essere proprio due allegroni. Immagino i discorsi durante le cene in famiglia: “Luc, ti devo raccontare una disgrazia…” — “Dimmi, Jean-Pierre, Dimmi!”. Però hanno fatto un film bello, ma bello veramente. Rosetta è allegro come il Cimitero Monumentale ed è una storia scontrosa di povertà senza riscatto nella ricca Europa del 2000. L’adolescente Rosetta, madre alcolizzata e padre boh, vive in una roulotte e sbarca il lunario con lavori di fortuna, sempre alla ricerca di un’assunzione che le dia un po’ di requie. Ma è un gran bel mondo di merda: Rosetta si adegua e in cambio di un posto di lavoro sicuro tradisce forse l’unica persona che le potrebbe dare un po’ d’affetto. Ma non durerà, perché di sicuro ormai non c’è più niente e la carognaggine paga solo se siete ricchi. Cinepresa inquieta sul volto mobile e puro di Emilie Duquenne, montaggio aspro, dialoghi veloci, scene strazianti: tutto senza la retorica della musica o del discorso a tesi. Come già nel bellissimo La promesse, anche qui i fratelli Dardenne vanno al sodo e raccontano per immagini una storia semplice, che fa male, ma che vale la pena ascoltare. Palma d’oro a Cannes nel 1999, Rosetta è un film duro, vero, rigoroso, incalzante, senza sconti né pentimenti. Ed è bello, sai? (Vhs da Tele+; 9/10/02)
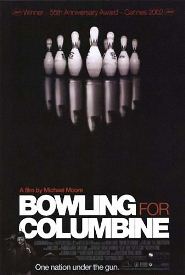 330 — Bowling a Columbine di un Michael Moore un po’ deludente, non malaccio, ma neanche… vabbeh, USA 2002
330 — Bowling a Columbine di un Michael Moore un po’ deludente, non malaccio, ma neanche… vabbeh, USA 2002
La pila di videocassette in attesa sul televisore è ormai imbarazzante. Barbara fa strani discorsi su ordine e mancanza di spazio e ho paura che le venga un furore igienico nazistoide e faccia piazza pulita: “rubano aria, sono in bianco e nero, i sottotitoli sono illeggibili”, dice, per concludere altezzosamente che “…il grande cinema si vede sul grande schermo” e bla bla bla. Finisce che quindi non si guardi nulla anche perché arriviamo dal lavoro, la sera, cotti come due brasati; sennonché, dopo 23 giorni di astinenza da nastro magnetico o pellicola impressionata, capita finalmente di andare a vedere questo Bowling a Colombine, dell’amato Michael Moore. Lo attendevo e pregustavo una grande prestazione: colleghi in visibilio, critici entusiasti, pubblico partecipe… e invece, devo dirlo, Bowling a Columbine è deludente. Se è la prima volta che vedete un film del corpulento scrittore-regista di Flint, Michigan, allora sarà tale il piacere e la sorpresa che troverete tutto fresco, divertente e intelligente. Se invece conoscete già sue opere precedenti non potete non notare quanto manchi a questo film un filo conduttore portante, intrigante, forte. Bowling parte da un tremendo fatto di sangue: nel giorno in cui, nel 1999, le forze americane scaricavano una marea di bombe sul Kosovo, a Columbine, nel Colorado, due studenti frustrati compivano una strage nella locale High School, abbattendo come birilli una decina di loro compagni e una insegnante. Il documentario si sviluppa come un’inchiesta sull’ossessione tutta americana per le armi. Perché gli statunitensi le amano così tanto? E soprattutto: perché si ammazzano tra di loro così di frequente? Moore gira per l’America e fa domande: alle milizie, agli appassionati, alle rockstar accusate di tutti i mali (Marylin Manson), ai genitori dei ragazzi assassinati. Poche risposte, tanti dubbi. Non c’è una soluzione, o forse ce ne sono migliaia, ma il film non persegue un risultato. E ne risente perché manca dell’unità, per esempio, di Roger and Me, dove noi spettatori eravamo trascinati verso l’incontro finale con il CEO della General Motors, Roger, appunto. Qui è tutto più frammentario. A tratti estremamente toccante, oppure divertente, ma manca quell’unità che rende grande il cinema. Questo Bowling a Columbine sembra un bel documentario (perché è un buon documentario, non vorrei essere frainteso), ma è drammaticamente televisivo nella mancanza d’unità stilistica e narrativa. È un film importante e coraggioso perché si prende il rischio di guardare in faccia la nazione e dirgli quanto faccia schifo chi la presiede. Ed è un film ricco dell’umanità di Michael Moore, questo caracollante ciccione che inchioda con l’innocenza delle sue domande i tanti che fanno le cose senza pensarci (si veda l’esemplare incontro con Charlton Heston: ma possibile che quest’uomo sia il più imbecille del Pianeta delle scimmie?). Film decente, dunque, ma che lascia insoddisfatti perché aspettavo (e volevo disperatamente) un capolavoro. Visto con pellicola tagliata in alto e in basso e leggera aberrazione dello schermo. So di essere ossessionato dalle corrette proiezioni e dal rispetto dei formati originali, ma se permettete “ti conosco, mascherino”, eh. (Cinema Anteo, Milano; 1/11/02)
 331 — La maledizione dello scorpione di giada dell’ipnotizzato Woody Allen, USA 2001
331 — La maledizione dello scorpione di giada dell’ipnotizzato Woody Allen, USA 2001
Ennesimo Allen veneziano e natalizio osannato dalla critica, esattamente come i due film precedenti, incensati e puntualmente invedibili. Per cui grande diffidenza da parte mia, anche perché se i critici mangiano tartine al Lido inebriati da una valpolicella, finisce sempre che gli piglia il magone nostalgico e celebrino Woody per quello che è stato e non per quello che è. A distanza di anni, poi, ritrattano ammettendo che la vena dell’autore newyorchese è in effetti svanita, ma quando si tratta di fargli pubblicità non si tirano mai indietro, riproponendo la trita formula: “il migliore Allen da anni”, formula che già contiene l’ammissione delle palle mendaci raccontate gli anni prima. Okay, fine dello sfogo, che se mi son rotto le palle io a scriverla, ‘sta cosa, figuriamoci voi a leggerla. E anche perché stavolta c’è qualche motivo per esprimersi positivamente e, almeno, questo è un film decente. Briggs è un ispettore assicurativo in lotta con l’amante del capo, la legnosa mrs. Ferguson. Una sera vengono entrambi ipnotizzati da un mago truffaldino che li tiene in suo potere (parole d’ordine “Costantinopoli” e “Madagascar”, sembra che la cosa faccia molto ridere. Boh) e fa compier loro dei furti eclatanti. Le cose si aggiusteranno e grazie all’ipnosi — o forse no — ci saranno anche sorprese sentimentali. Tante battute (alcune buone, altre meno) e vitalità: da cinque anni a questa parte direi che è la cosa migliore di Allen, perché dopo il geniale ma malriuscito Harry a pezzi erano venuti il tremendo Celebrity — probabilmente il più brutto film di Woody di sempre -, Accordi e disaccordi — pretenzioso e noiosissimo —, e Criminali da strapazzo — che ho rifiutato di vedere, convinto da troppi amici esterrefatti. In questa Maledizione, invece, ci sono tanti sintomi di buona salute, non ultimo l’utilizzo parchissimo dello zoom. Ma che c’entra? C’entra, altroché se c’entra: Allen vuole sempre risparmiare tempo e soldi, e non manca mai di ricordarlo cinicamente, e per questo motivo preferisce lo zoom ai carrelli. Risparmierà soldi, okay, però poi, visivamente, il film fa cagare, è sgraziato e inelegante. E forse qualcuno glielo ha ricordato, perché qui, stavolta, c’è una cura che sembrava scomparsa. L’intreccio è intrigante, sono buoni i dialoghi e solo la soluzione del mistero e il finale sono un po’ buttati via. Nel cast un Dan Aykroyd ormai diventato un mostruoso Gabibbo in carne e ossa e una Helen Hunt secca e brutta come il peccato ma decisamente brava. E poi c’è Charlize Theron, la fatalona cui si sfilacciava il culetto in uno spot della Martini, ormai lanciata nel cinema. E vabbeh, megiu che ninte! Woody Allen ci aveva abituato a ben altre cose, ma visto l’andazzo questo è un film piacevole, dài! (Vhs da Tele+; 2/11/02)
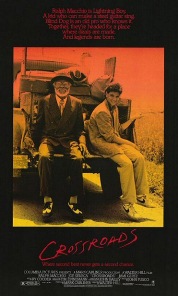 332 — Mississippi Adventure del cialtrone Walter Hill, USA 1986
332 — Mississippi Adventure del cialtrone Walter Hill, USA 1986
Sono un appassionato di musica blues, da quella delle origini fino alle “corruzioni” successive, anche le più cafoni, e ho sognato a lungo di diventare un bluesman io stesso. Non si sa come un pallido genovese, figlio della borghese Albaro, scarso alla chitarra e alla voce, privo di qualunque senso del ritmo e comunque dai gusti pacchiani, potesse arrivare a tanto, ma s’è giovani per sognare, eccheccazzo. E il film di stasera è un po’ la concretizzazione su pellicola di quel mio sogno infantile coltivato in età fin troppo matura. Ergo, è un film stupido. Molto, a prima vista. Ma gioca col Mito e se non andate troppo per il sottile può risultare anche divertente. La sceneggiatura gioca con i luoghi comuni del Blues (esperienze sulla strada, hoboing, l’anima venduta al diavolo etc.) e sfiora spesso la pacchianeria, ma se non altro la musica — quando non si svacca, come si vedrà nel finale — è bella e autentica. Comunque: Eugene, figlio di genitori divorziati, studia alla prestigiosa Juillard di New York. Impara i classici della chitarra ma ama il blues e ha un piano (che, tra le tante idee che possono venire a uno sceneggiatore, rasenta la follia): vuole trovare la trentesima canzone di Robert Johnson, quella mancante alla session che consegnò il leggendario bluesman alla storia (per dire, è quello che ha scritto, o trascritto, le versioni originali di Sweet Home Chicago, I Believe I’ll Dust My Broom, Rambling On My Mind, Hellhound On My Trail, Travelling Riverside Blues etc., etc., se no non si finisce più). E per trovare il brano musicale che potrebbe lanciare la sua carriera (in effetti gli ascoltatori del 1986, tra un pezzo dei Kajagoogoo e uno degli A-ha, non aspettavano altro!), Eugene ricorre a un armonicista rinchiuso in un ospedale per detenuti. Si tratta del Willie Brown citato da Robert Johnson in Crossroads, anche se lui nega. Lo aiuta a fuggire e assieme arriveranno fino al Delta, dopo diversi picareschi incontri. La trama è bambinesca, lo sviluppo tra il noioso e l’insultante e il succo è che il vecchio bluesman passa la sua arte, poco a poco, al moccioso. Nella fattispecie il moccioso è Ralph Macchio, che cammina dondolando come Tony Manero e per lo più esibisce un sorrisone dentuto pre-sviluppo. Anche se dimostra 14 anni sostiene di averne 17 ed esercita la sua virilità con una vagabonda incontrata per caso (lo sceneggiatore avrà pensato che se vaccata doveva essere, tanto valeva che lo fosse al massimo livello). Si arriva a un finale che è l’unica cosa che dà realmente senso alla visione di questa oscitante pellicola: Willie Brown deve infatti rendere l’anima al diavolo (e certo, mica farò lo schizzinoso a questo punto, eh) ma non sarà così se Eugene batterà a duello (chitarristico) un altro posseduto, tal Jack Butler, cioè il pirotecnico chitarrista iperveloce Steve Vai. Fuoco alle polveri ed ecco un duello d’antologia, dove si parte con la pentatonica e si conclude con i fraseggi neoclassici del metal anni Ottanta, strapazzando un Capriccio di Paganini. Ovviamente vince il Macchio selvaggio, ma la scena è gustosa e la musica ignorante e gagliarda, anche se nulla ha a che spartire col blues. Tra l’altro l’attorucolo (pressoché scomparso dopo aver interpretato altri due Karate Kid) mette le mani nei posti giusti, ma quando è il momento del duello si vede che le immagini sono clamorosamente accelerate per stare al passo con la musica. Alla fin fine questo Mississippi Adventure m’è passato: una cacirrata con un quarto d’ora finale estremamente divertente, anche se per meri motivi musicali. La colonna sonora tradizionale curata da Ry Cooder, poi, è splendida, nonostante qualche sonorità moderna. (Vhs da RaiUno; 9/11/02)
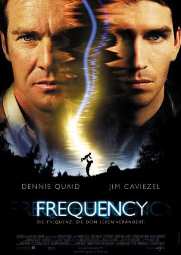 333 — Frequency del paradossale Gregory Hoblit, USA 2000
333 — Frequency del paradossale Gregory Hoblit, USA 2000
Barbara insiste per vedere in diretta Tv questo Frequency. Protesto con civile maturità, battendo i piedi e piagnucolando che non capisco perché, avendo raccolto tutta la storia del cinema in Vhs, mi debba sorbire un filmaccio USA che puzza di sòla fantascientifica lontano un miglio. E chi vince, secondo voi? Vabbeh, lo ammetto: Frequency cresce pian piano, s’insinua, ammalia e alla fine piace pure. John, un agente di polizia, ricorda l’infanzia felice col padre pompiere ormai morto e deve affrontare un presente di solitudine e incertezza. Ma poi tira fuori una vecchia radio, il baracchino a cui il padre stava attaccato tutte le sere. E riaccendendola accade l’incredibile: trova la comunicazione proprio con lo stesso apparecchio, ma trent’anni prima quando dall’altra parte del filo c’era il padre. Non fa una piega. All’inizio i due non si capiscono (e francamente…), poi non tentano di spiegarsi più il paradosso temporale, ma ne sfruttano le potenzialità e John insegna al padre come sfuggire alla morte. La modifica del passato però ha anche altre incidenze sul presente e i due salveranno la madre (e moglie) da un serial killer. Insomma: si parte come fantascienza e si finisce come thriller, dove la lotta contro il tempo avviene in due epoche. In più le scene ambientate nel 1969 presentano in rapida successione Sookie Sookie degli Steppenwolf, Rattlesnake Shake dei Fleetwood Mac e On the Road Again dei Canned Heat: piccole gocce di estasi musicale. Recitato decentemente da Dennis Quaid e Jim Caviezel, narrato e montato con agilità, Frequency non perde un colpo e la sceneggiatura funziona, anche se la coerenza dei paradossi temporali viene presto dimenticata (e perché non lasciare il dubbio che qualcosa potrebbe andare storto, piuttosto che servirci un finale un po’ dolciastro? Ma che ne so io, dai…). Oh, aveva ragione quella là. E adesso, Ejzenstejn, Pudovkin e Vertov? (Diretta su RaiDue; 13/11/02)
 334 — Taking Off, il decollo geniale di Milo Forman, USA 1971
334 — Taking Off, il decollo geniale di Milo Forman, USA 1971
Taking Off aspettavo di rivederlo da almeno dieci anni. È uno di quei film che nel ricordo e col passare del tempo ha assunto una statura mitica, un po’ come altri miei capisaldi, tipo L’ultima corvée, Soldato blu, Piccolo grande uomo, Piccoli omicidi o Vivere alla grande (film che difenderò alla morte, sempre, anche se rivedendoli avrò magari dei dubbi). Questo me lo fece vedere per la prima volta durante gli anni Ottanta babbo Luciano, che ne era entusiasta: Taking Off è la prima opera americana dell’esule ceco Milo Forman ed è la storia di una generazione di genitori alla ricerca dei figli fuggiti di casa: per Forman gli Stati Uniti, in cui è appena arrivato dopo la repressione della Primavera di Praga, sono una nazione che cerca disperatamente di capire cosa vogliano ‘sti ragazzi, perché scappino e cosa cerchino nella fuga. L’innocente Jeannie Tyne è andata a provare un’audizione musicale. I genitori vanno in crisi e quando la beata figliola torna a notte fonda non si calmano per niente: l’interrogatorio cui la sottopongono convince la quindicenne che è venuto il momento di andarsene di nuovo. E qui comincia il delirio perché i due genitori, repressi, massificati, rimbambiti, aderiscono alla Società Genitori Figli Scappati e provano la marijuana (è la sequenza immortale in cui l’esperto di problematiche giovanili li invita a spipacchiarsi una canna: “Prendete la paglia…”), sognano la liberazione sessuale e si concedono un patetico e disinibito strip poker. Le conseguenze di tutto ciò saranno evidenti alla figlia allibita che porta in casa il fidanzato musicista, un tipo disinteressato al denaro, ma che guadagna 290mila dollari all’anno suonando. Forman fotografa vezzi, tic, manie, comportamenti inibiti, la moda e le mode, il kitsch, le ossessioni dell’americano medio di fronte alla contestazione o alla nuova consapevolezza dei giovani della Woodstock Generation. Un film con tempi lunghi, pochissima trama, ma tantissime situazioni particolareggiate, dove si sorride spesso. Per me era un film epocale: rivisto, confermo l’affetto spropositato che mi lega alla pellicola. Tra le tante facce che girano durante il provino iniziale (montato magnificamente in parallelo al terrore genitoriale) ci sono anche Jessica Harper, Kathy Bates e la cantante Carly Simon. Nonostante abbia visto Taking Off in tivù almeno due volte, la messa in onda notturna di Retequattro vantava di essere un’improbabile “prima”. (Vhs da Retequattro; 20/11/02)
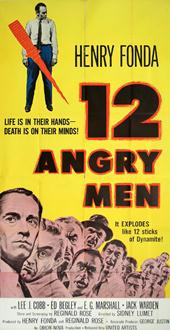 335 — 12 Angry Men del favolistico Sidney Lumet, USA 1957
335 — 12 Angry Men del favolistico Sidney Lumet, USA 1957
Un caso giudiziario la cui sentenza sembra già scritta: dodici giurati devono dare il loro assenso alla condanna alla sedia elettrica di un ragazzino, accusato di aver accoltellato il padre come un centrino. Ma serve un voto unanime di colpevolezza, se no bisognerà rifare il processo. Fa parte della giuria Henry Fonda, il vecchio democratico dalla faccia da scimpanzé, che fa una bella pensata: non sa se il ragazzino sia innocente, ma ha il ragionevole dubbio che non sia colpevole e tanto gli basta per mettere in discussione la frittura sulla sedia. Irritazione comprensibile degli altri: l’unanimità non c’è. Inizia un’ora e mezzo di schermaglie verbali in cui Fonda, architetto, colto, difensore dei diritti dei più deboli e dotato di ferrea logica, smonta le certezze dei suoi compagni giurati e, cui, uno a uno, prova a instillare il “ragionevole dubbio”. Il congegno narrativo, pur se prevedibile, è teso come una corda di violino. I dodici personaggi sono perfetti stereotipi del cittadino (americano), dal razzista all’immigrato, dall’istruito al caprone, dal coraggioso al vigliacco, dall’altruista all’egoista, etc. Ma sono scritti benissimo: con pochi tratti essenziali e con qualche twist che eviti la banalità. E in più ci sono dodici grandi attori. Tolta qualche ingenuità di fondo, La parola ai giurati è bello potente, una gioiosa macchina d’intrattenimento che riesce, nella sua semplicità, a far riflettere anche oggi, 45 anni dopo la sua realizzazione. Visto in Dvd in splendente formato widescreen. Non ci sono extra di sorta, ma non me ne frega una cippa: vedere la ratio rispettata, ascoltare le vere voci degli attori e apprezzare la fotografia definita sono gioie impagabili cui, in futuro, sarà difficile rinunciare. Tra l’altro la direzione della fotografia è di Boris Kaufman, fratello minore di Dziga Vertov e operatore dei film di Jean Vigo che ho amato in gioventù. Vabbeh, chissenefrega ma neanche troppo. Film candidato a quattro Oscar, non vinse nulla perché, cazzo, siamo democratici ma non esageriamo, eh? Nel cast stellare anche Lee J. Cobb (il padre deluso dal figlio), Jack Warden (il tifoso di baseball) e Martin Balsam (il presidente della giuria). Bello bello. Ma è solo un film. (Dvd; 30/11/02)
Qui le altre puntate di Divine Divane Visioni
(Continua — 28)



